La Guerra e il Fascismo a Lecco nel racconto di Giancarla Pessina: proiezione in una sala piena
Una Lecco non così lontana nel tempo, quella raccontata venerdì sera in Sala Ticozzi, ma sicuramente molto diversa da quella a cui siamo abituati. È la Lecco della Seconda guerra mondiale, del fascismo e della resistenza, vista con gli occhi di una bambina di nove anni che il giorno di Natale del 1939 si è vista stravolgere la vita e quella della sua famiglia: i suo fratelli - gemelli ed entrambi diciottenni - hanno ricevuto la "cartolina rosa", sarebbero cioè di lì a poco dovuti partire per quella guerra a cui l'Italia di Mussolini stava per prendere parte. Quella bambina era Giancarla Riva, più nota come Giancarla Pessina, perché suo marito - Emilio Pessina - "era stato partigiano" come ha spiegato lei stessa nella testimonianza video raccolta da Qui Lecco libera con la collaborazione dell'Anpi di Lecco e proiettata per la prima volta proprio venerdì in una sala gremita e che sarà presto disponibile sul sito dell'associazione oltre che per le scuole.

Giancarla Riva Pessina
Quella di Giancarla era una famiglia antifascista, i suoi genitori erano del 1888 e suo padre era un "vecchio socialista", era stato perseguitato dai fascisti, era stato picchiato e aveva perso la licenza del suo negozio. La famiglia di sua madre aveva perso tanti uomini durante le cosiddette guerre imperiali della monarchia e questa nuova chiamata alle armi era stata vissuta come una vera tragedia: niente più feste in casa Riva, neanche per il compleanno di Giancarla in occasione del quale "la mamma mi faceva la 'miascia', la torta fatta con il pane raffermo". E non solo a casa le cose cambiarono: a scuola durante la ricreazione non si giocava più, ma "stavamo lì a zappettare l'orto di guerra" che era stato allestito in un pezzettino del cortile della scuola Carducci. "Ogni settimana poi, dovevamo scrivere una lettera ai soldati, per incoraggiarli", una lettera pre-dettata dall'insegnante con frasi altisonanti. E la vita cambiò un po' per tutti: nelle fabbriche cominciarono ad entrare le donne, che presero letteralmente il posto degli uomini che erano partiti, "perché la produzione bisognava mandarla avanti. Alla Bonaiti sono state cinque le donne arrestate e portate in campo di concentramento. Le donne hanno anche sostituito i servizi sociali per tutta la famiglia: gli anziani e i bambini erano a loro carico e in più dovevano pensare al mantenimento economico della famiglia. Gli anziani venivano ricoverati a Germanedo quando non c'erano alternative e io dovevo andare per ordine di mia mamma a trovare dei conoscenti per portare i toscani, il vino, il cedro o i mentini".
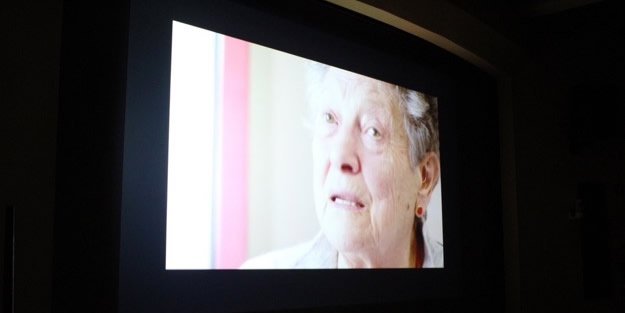
La protagonista sullo schermo e con Duccio Facchini di Qui Lecco Libera

Alle famiglie veniva chiesto di contribuire alle spese militari con "l'obolo di guerra": bisognava donare la fede, il "secchiello dell'acqua" usato per bere l'acqua potabile o altri beni personali fatti in metalli preziosi come l'oro e il rame. "C'era una paura diffusa alla disobbedienza, ma non tutte consegnarono la vera, mia madre non la consegnò per esempio, pur litigando con mio papà che aveva paura di essere segnalato. Alla fine si decise di portare qualcosa di vecchio: una pentola malandata e un paiolo". Nel frattempo uno dei fratelli di Giancarla, Pino, era stato spedito in guerra in Grecia dove ebbe modo di incontrare un ragazzo di Laorca e uno di Acquate (Meles e Turba, i loro cognomi): "Così cominciò un rito, quando uno dei ragazzi spediva una lettera e questa arrivava a casa bisognava fare il giro dei tre quartieri, perché ognuno dei ragazzi dava notizie anche degli altri e la frase che queste mamme pronunciavano ogni volta che leggevano la lettera era 'almeno fino a giovedì passato erano ancora vivi'. Giravo per la città anche quando c'era la distribuzione del sale, che era un alimento tesserato ma per il quale non c'era la tessera annonaria, per noi era quasi un gioco metterci in fila nel rione dove sapevamo ci fosse la consegna del sale".

E poi è arrivata la Resistenza: "Io non so come funzionava il soccorso rosso, ma c'era in città ed era gestito dalle donne, che procuravano tutto il necessario agli uomini per sopravvivere, in me si è formata l'idea che senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza". Fu in quel periodo che Antonio Piloni - guida alpina - scampò per la seconda volta alla cattura dei fascisti e in quella circostanza ebbero fortuna anche i suoi due fratelli: "Uno di loro si era ammalato di tifo ed era stato portato ospedale ma grazie al dottor Frigerio, primario di medicina attento ai partigiani, è stato nascosto e curato nella stanza delle lenzuola sporche; invece l'altro mio fratello e Piloni erano tornati a casa per salutare la famiglia, abitavamo nello stesso cortile e qualcuno fece la spia. Un nostro conoscente un certo Domenico avvertì Piloni di scappare e chiese a me di dire che non avevo le chiavi di casa perché c'era mio fratello che dormiva. Arrivò ufficiale che vide la finestrella del bagno aperta e ci si infilò. Però non riuscì ad uscire dalla porta e ad entrare in casa perché al posto di tirarla la spinse e così tornò indietro uscendo nuovamente dal finestrino. Quando vidi la scena non potei che scoppiare a ridere, fu l'unico sberlotto sonoro - quello del fascista - che ho preso nella mia vita". Rispetto al 25 aprile Giancarla Pessina ha raccontato un ricordo affatto scontato, riportando un episodio forse rimosso dalla coscienza collettiva: dopo la liberazione i partigiani si riversarono nelle strade e sorsero nelle piazze della città dei banchetti dove i combattenti scesi dalle montagne si incontravano e assieme alla compagine antifascista della società cercavano di ripartire.

M.V.















