Calolzio: professore aretino dedica un libro a Celeste Ausenda, antifascista ed esule
Dimenticata del tutto, forse no. Periodicamente, il suo nome esce dall’ombra. Nel 2013 fu l’Anpi a ricordarne la figura e cinque anni fa la lista civica “Cambia Calolzio” la inserì in un elenco di donne alle quali intitolare una via. Si parla di Celeste Ausenda, nata nel 1893 e cresciuta a Treviglio, poi traferitasi a insegnare a Cremona, esule per antifascismo in Francia facendo riferimento al gruppo di “Giustizia e libertà” dei fratelli Rosselli, confinata a Ventotene, partigiana azionista, visse i suoi ultimi anni a Calolziocorte, abitando per una singolare coincidenza nella via intitolata a don Achille Bolis, l’arciprete ucciso di botte dai nazifascisti nel carcere di San Vittore a Milano nel febbraio 1944. Ammalatisi, Celeste Ausenda morì all’ospedale di Lecco nel 1971. E’ sepolta nel cimitero di Calolziocorte. Ora, quella vita, sta per diventare un libro. Alcune lettere ritrovate casualmente in un archivio di Sansepolcro, in Toscana, hanno infatti convinto un docente aretino ad approfondire la storia di Celeste Ausenda, riuscendo a raccogliere una gran mole di informazioni tanto da parlare di una monografia corposa. Con qualche lacuna relativa proprio agli anni calolziesi. Per colmare la quale, il docente – Giorgio Sacchetti che ha insegnato all’Aquila, Padova e Firenze, già autore di saggi storici sul Novecento, il fascismo e la Resistenza - in questi giorni ha pubblicato in internet, sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…”, un annuncio alla ricerca di testimonianze, di persone che abbiano notizie degli anni trascorsi nel capoluogo della val San Martino da Ausenda o se addirittura non abbiano incontrato lei o il compagno Arturo Amigoni, morto nel 1974.
Ora, quella vita, sta per diventare un libro. Alcune lettere ritrovate casualmente in un archivio di Sansepolcro, in Toscana, hanno infatti convinto un docente aretino ad approfondire la storia di Celeste Ausenda, riuscendo a raccogliere una gran mole di informazioni tanto da parlare di una monografia corposa. Con qualche lacuna relativa proprio agli anni calolziesi. Per colmare la quale, il docente – Giorgio Sacchetti che ha insegnato all’Aquila, Padova e Firenze, già autore di saggi storici sul Novecento, il fascismo e la Resistenza - in questi giorni ha pubblicato in internet, sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…”, un annuncio alla ricerca di testimonianze, di persone che abbiano notizie degli anni trascorsi nel capoluogo della val San Martino da Ausenda o se addirittura non abbiano incontrato lei o il compagno Arturo Amigoni, morto nel 1974.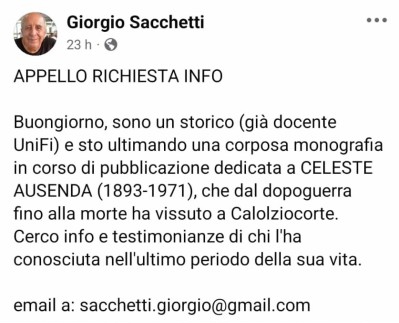
Sacchetti è comunque riuscito a ricostruire gran parte di una vita avventurosa, ma delineando non tanto il ritratto di una rivoluzionaria intrepida quanto di una donna fragile per quanto impegnata e a volte fin troppo decisa quasi a rasentare l’incoscienza che sarebbe stato motivo d’attrito coi compagni di lotta. E ciò magari farà discutere.
Sacchetti racconta così la decisione di dedicarsi a questa storia: «Un giorno mi trovavo all’Archivio diocesano di Sansepolcro alla ricerca di alcuni documenti sulla Resistenza aretina, quando un amico che lavora lì mi indicò un epistolario di una cinquantina di lettere inviate a Pompeo Ghezzi, vescovo di Sansepolcro dal 1912 al 1953, ma in precedenza curato di Treviglio dal 1893 al 1911. E sono, quelli, gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza di Celeste Ausenda. Che don Pompeo quindi conobbe da bambina a ragazzina».
Negli anni Trenta, l’ormai cresciuta Celeste si era trasferita a insegnare latino in una scuola di Cremona. E all’epoca, Cremona voleva dire Roberto Farinacci, uno dei più fanatici dirigenti del Fascismo. Secondo Sacchetti, Ausenda non sarebbe stata una vera e propria oppositrice del Regime, preferisce definirla «una antifascista esistenziale» e cioè una delle tante persone che viveva con profondo disagio il clima farinacciano che si respirava a Cremona. Però, intorno al 1936, fu la sua casa a diventare un luogo di ritrovo di persone di provenienze differenti (colleghi insegnanti, sindacalisti cattolici, comunisti, socialisti) che crearono una sorta di “cenacolo antifascista”. «C’erano anche donne – dice Sacchetti – ma si trattava soprattutto di uomini. E quel via vai alimentò una serie di voci che allertarono la Questura. La quale, però, suppose che quello non fosse un ritrovo di antifascisti bensì una casa di appuntamenti. Tra i frequentatori del cenacolo c’era anche Arturo Amigoni, un commerciante che intrecciò una relazione con Celeste. Il problema era che lui era già sposato. Tanto che, quando nel gennaio 1937 i due lasciarono Cremona e l’Italia per riparare a Parigi, le autorità puntarono sulla versione dello scandalo parlando della fuga di due amanti».
A Parigi, presero contatto con i fuoriusciti di “Giustizia e libertà”, tra i quali Ausenda dovette avere un ruolo non del tutto secondario. Solo che il gruppo contava non pochi infiltrati della polizia politica fascista, l’Ovra. Che nell’estate del 1937 scoprirono un piano per una campagna antifascista da promuovere a Cremona. L’esito fu che la rete antifascista cremonese venne smascherata e si verificarono arresti in massa. L’episodio alimentò non poche discussioni all’interno di “Giustizia e libertà”: Ausenda e Amigoni vennero accusati di imprudenza e in qualche misura emarginati.
Quando, nel 1940, la Germania invase la Francia, Ausenda venne arrestata, deportata in Germania e poi estradata in Italia dove venne giudicata dal Tribunale speciale, carcerata alle Mantellate, percossa e torturata e infine confinata a Ventotene. Proprio durante la carcerazione romana, percosse e torture la costrinsero a molte confessioni, dice ancora lo storico Sacchetti. E sono proprio queste confessioni a fargli parlare della fragilità del personaggio. Una fragilità che emerge proprio dalle lettere che da Roma e Ventotene, la donna indirizzò a don Pompeo Ghezzi che l’aveva ritrovata ed era anche venuta a incontrarla alle Martellate, l’aiutava come aiutava altri prigionieri. E in quelle lettere Ausenda parlava delle proprie paure.
Nel 1943, con la caduta del Fascismo, venne liberata come altri confinati, rientrò a Roma ed entrò in clandestinità, salì a Milano dove operò con le Brigate Matteotti, più con ruoli di “intelligence” che di lotta armata, secondo la ricostruzione di Sacchetti. Fu lei, infatti, a intervenire a nome di “Giustizia e libertà” per evitare che un gruppo di partigiani fucilasse l’ingegner Nono Mori, architetto cremonese del Littorio ma soprattutto farinacciano di ferro. Intervento che non riuscì, perché Mori venne giustiziato comunque.
Finita la Guerra, Ausenda e Amigoni si stabilirono a Milano e avrebbero voluto regolare i conti con quelle spie che li avevano fatti arrestare. Nel 1946 scrissero a Ferruccio Parri e ai dirigenti del Partito d’Azione indicando nome per nome le spie e chiedendo giustizia. Il clima di quei mesi è raccontato in tutti i libri di storia. Le denunce dei due finirono con l’essere accantonate per le ragioni più diverse e le loro sollecitazioni mal tollerate. Poi, il trasferimento a Calolziocorte, che Sacchetti sta cercando di approfondire.

Celeste Ausenda
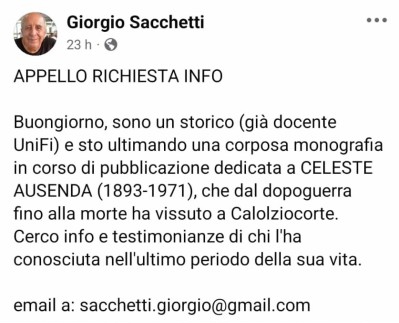
Il post con la richiesta del professor Sacchetti
Sacchetti è comunque riuscito a ricostruire gran parte di una vita avventurosa, ma delineando non tanto il ritratto di una rivoluzionaria intrepida quanto di una donna fragile per quanto impegnata e a volte fin troppo decisa quasi a rasentare l’incoscienza che sarebbe stato motivo d’attrito coi compagni di lotta. E ciò magari farà discutere.
Sacchetti racconta così la decisione di dedicarsi a questa storia: «Un giorno mi trovavo all’Archivio diocesano di Sansepolcro alla ricerca di alcuni documenti sulla Resistenza aretina, quando un amico che lavora lì mi indicò un epistolario di una cinquantina di lettere inviate a Pompeo Ghezzi, vescovo di Sansepolcro dal 1912 al 1953, ma in precedenza curato di Treviglio dal 1893 al 1911. E sono, quelli, gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza di Celeste Ausenda. Che don Pompeo quindi conobbe da bambina a ragazzina».

Il professor Giorgio Sacchetti
Negli anni Trenta, l’ormai cresciuta Celeste si era trasferita a insegnare latino in una scuola di Cremona. E all’epoca, Cremona voleva dire Roberto Farinacci, uno dei più fanatici dirigenti del Fascismo. Secondo Sacchetti, Ausenda non sarebbe stata una vera e propria oppositrice del Regime, preferisce definirla «una antifascista esistenziale» e cioè una delle tante persone che viveva con profondo disagio il clima farinacciano che si respirava a Cremona. Però, intorno al 1936, fu la sua casa a diventare un luogo di ritrovo di persone di provenienze differenti (colleghi insegnanti, sindacalisti cattolici, comunisti, socialisti) che crearono una sorta di “cenacolo antifascista”. «C’erano anche donne – dice Sacchetti – ma si trattava soprattutto di uomini. E quel via vai alimentò una serie di voci che allertarono la Questura. La quale, però, suppose che quello non fosse un ritrovo di antifascisti bensì una casa di appuntamenti. Tra i frequentatori del cenacolo c’era anche Arturo Amigoni, un commerciante che intrecciò una relazione con Celeste. Il problema era che lui era già sposato. Tanto che, quando nel gennaio 1937 i due lasciarono Cremona e l’Italia per riparare a Parigi, le autorità puntarono sulla versione dello scandalo parlando della fuga di due amanti».
A Parigi, presero contatto con i fuoriusciti di “Giustizia e libertà”, tra i quali Ausenda dovette avere un ruolo non del tutto secondario. Solo che il gruppo contava non pochi infiltrati della polizia politica fascista, l’Ovra. Che nell’estate del 1937 scoprirono un piano per una campagna antifascista da promuovere a Cremona. L’esito fu che la rete antifascista cremonese venne smascherata e si verificarono arresti in massa. L’episodio alimentò non poche discussioni all’interno di “Giustizia e libertà”: Ausenda e Amigoni vennero accusati di imprudenza e in qualche misura emarginati.
Quando, nel 1940, la Germania invase la Francia, Ausenda venne arrestata, deportata in Germania e poi estradata in Italia dove venne giudicata dal Tribunale speciale, carcerata alle Mantellate, percossa e torturata e infine confinata a Ventotene. Proprio durante la carcerazione romana, percosse e torture la costrinsero a molte confessioni, dice ancora lo storico Sacchetti. E sono proprio queste confessioni a fargli parlare della fragilità del personaggio. Una fragilità che emerge proprio dalle lettere che da Roma e Ventotene, la donna indirizzò a don Pompeo Ghezzi che l’aveva ritrovata ed era anche venuta a incontrarla alle Martellate, l’aiutava come aiutava altri prigionieri. E in quelle lettere Ausenda parlava delle proprie paure.
Nel 1943, con la caduta del Fascismo, venne liberata come altri confinati, rientrò a Roma ed entrò in clandestinità, salì a Milano dove operò con le Brigate Matteotti, più con ruoli di “intelligence” che di lotta armata, secondo la ricostruzione di Sacchetti. Fu lei, infatti, a intervenire a nome di “Giustizia e libertà” per evitare che un gruppo di partigiani fucilasse l’ingegner Nono Mori, architetto cremonese del Littorio ma soprattutto farinacciano di ferro. Intervento che non riuscì, perché Mori venne giustiziato comunque.
Finita la Guerra, Ausenda e Amigoni si stabilirono a Milano e avrebbero voluto regolare i conti con quelle spie che li avevano fatti arrestare. Nel 1946 scrissero a Ferruccio Parri e ai dirigenti del Partito d’Azione indicando nome per nome le spie e chiedendo giustizia. Il clima di quei mesi è raccontato in tutti i libri di storia. Le denunce dei due finirono con l’essere accantonate per le ragioni più diverse e le loro sollecitazioni mal tollerate. Poi, il trasferimento a Calolziocorte, che Sacchetti sta cercando di approfondire.
D.C.




















