Festival Treccani: le parole per comprendere i cambiamenti del mondo
Giornata clou, quella di ieri, per il festival Treccani della lingua italiana in corso in questi giorni a Lecco con la parola “responsabilità” al centro della riflessione dell’edizione di quest’anno.

I lavori sono stati aperti in mattinata dalla storica del design Domitilla Dardi con una relazione su “La rivoluzione del rammendo. La responsabilità di dar durare le cose”. Tema, i legami tra il design, la produzione industriali, il consumismo con i “bisogni indotti” dei consumatori. Delle responsabilità di ciascuno di questi soggetti in quella rincorsa alla novità che condiziona la vita quotidiana. Sottolineando come spesso per design si sia portati a pensare a oggetti se non di lusso quanto meno di una ricercatezza particolare destinata a un pubblico che se li può permettere, quando in realtà tutto quanto ci circonda è frutto di design.

Dardi ne ha raccontato l’evoluzione, gli approfondimenti di sociologhi, gli esperimenti spesso fallimentari di designer importanti a proposito di riutilizzo dei materiali, di riconversione di oggetti precedenti, di “rammendi” appunto. Un esempio che la dice lunga sulla nostra società è quello della bicicletta: è un prodotto che per materiali e componenti può durare 25 anni, ma in realtà negli Stati Uniti succede che viene utilizzato per soli due anni, dopo di che viene riciclata sui mercati del Paesi in via di sviluppo dove finisce per durare 75 anni. Evidentemente occorre un ripensamento che deve passare attraverso il rapporto diretto tra designer e utente.
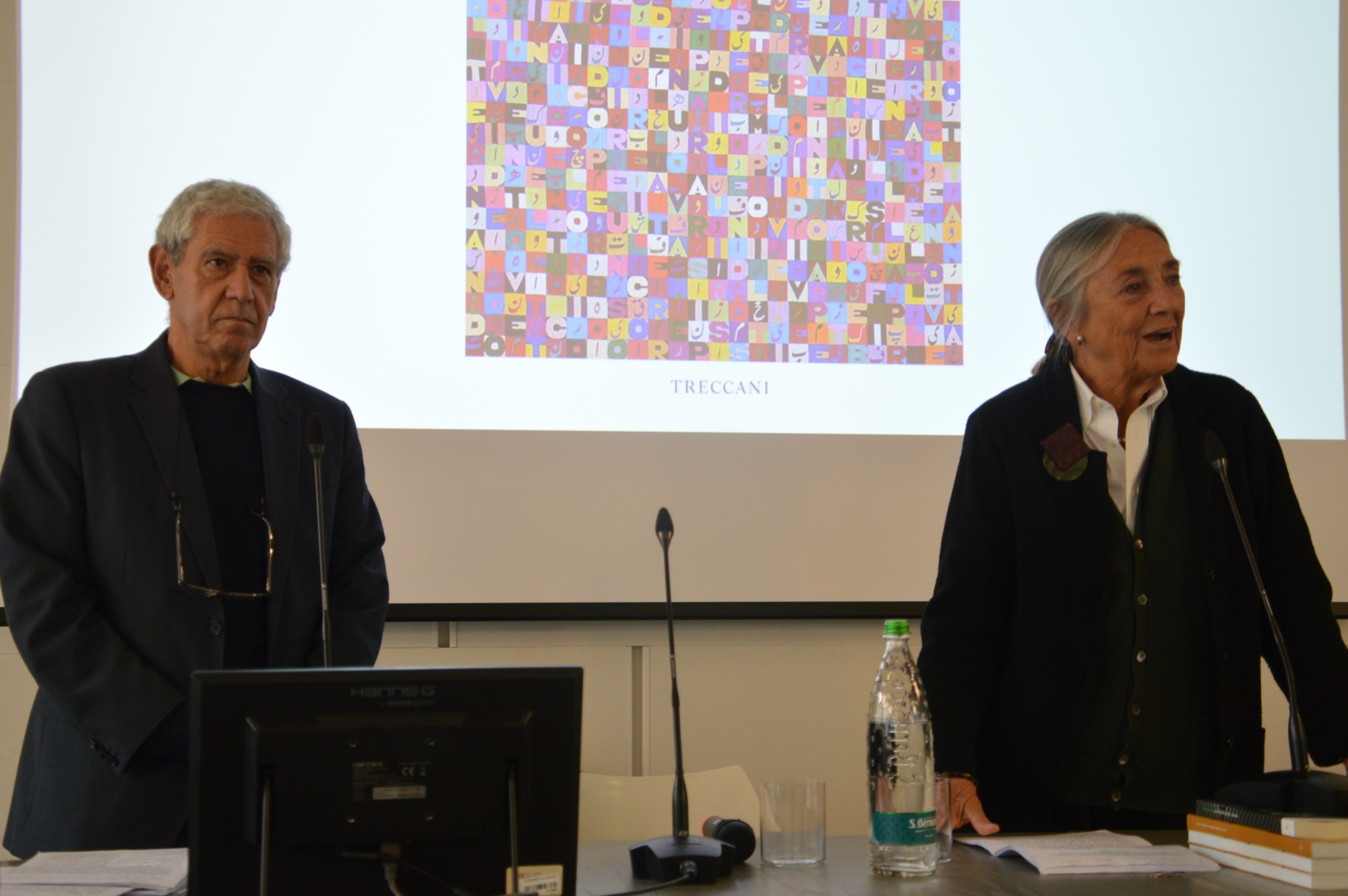
E’ stata poi la volta di Giuseppe Patota e Valeria Della Valle, curatori del Dizionario della lingua italiana realizzato dalla Treccani. I due relatori si sono alternati al microfono nel raccontare la storia e l’evoluzione della lingua italiana attraverso un viaggio immaginario nel tempo e in giro per l’Italia: da Lecco ad Assisi dove nel 1224-25, san Francesco ha scritto il “cantico delle creature” che è il primo testo in volgare.

Dall’Umbria si risale a Firenze dove nel 1265 nacque Dante: la sua “Divina Commedia” è stata il nocciolo iniziale della lingua italiana. Da Firenze si sale a Venezia dove nel 1500 Pietro Bembo scrisse la prima grammatica italiana basandosi sui testi di Petrarca e Boccaccio, considerando quello di Dante un fiorentino contaminato da espressioni “basse”, popolari. E si ritorna di nuovo a Firenze dove un’accolita di buontemponi si trasformò per l’intervento di Luigi Salvati nell’Accademia della Crusca che nel 1612 pubblicò il primo Vocabolario della lingua italiana.
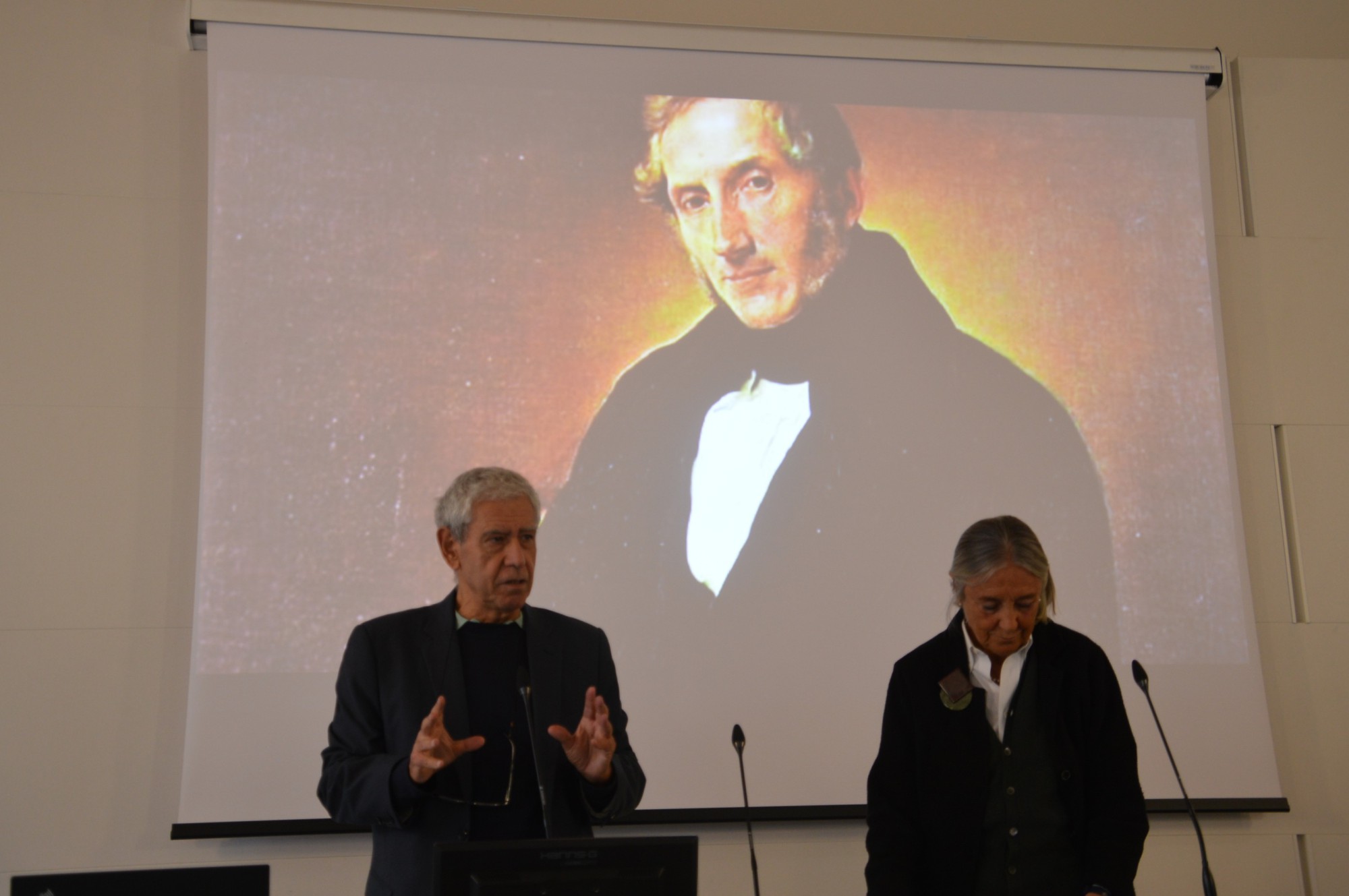
La tappa successiva è un ritorno a Lecco dove nell’Ottocento Alessandro Manzoni vi ambientò i suoi “Promessi sposi” in una lingua del quale non era contento, decidendo così di riportarci a Firenze per la famosa “risciacquatura” in Arno, per misurarsi cioè con il fiorentino parlato comunemente alla ricerca di una lingua che non fosse solo quella dei letterati ma comprensibile dai più. E con la successiva edizione del romanzo fondò praticamente l’Italiano moderno.

Successivamente, la linguista Beatrice Cristalli tracciato invece un’evoluzione storica della parola “responsabilità”, del concetto prima e del lemma poi. Partendo da Caino, quando a Dio risponde con quella fatidica domanda “Sono forse io il custode mio fratello” che in fondo altro non significa che negare ogni responsabilità nei confronti di Abele. In realtà, la parola “responsabilità” compare per la prima volta nel Settecento con le leggi della Repubblica Cisalpina per essere poi recepita nel 1876 dal Vocabolario del Tommaseo.

Andando oltre, Cristalli ha ricordato come la responsabilità abbia spesso un’accezione negativa, sottolineando peraltro come tutti la invochino ma generalmente nessuno se la vuole assumere. Per concludere ricordandone la concretezza, perché responsabilità – dal cui tronco fioriscano anche “sposi” – significa promessa e quindi impegno. La parola ha così la possibilità di creare essa stessa le cose. Responsabilità è una parola sociale ma che ha bisogno dell’agire e del fare.

Di “letteratura tra disimpegno e vocazione terapeutica” ha invece parlato Walter Siti, scrittore e critico letterario (curatore tra l’altro dei “Merdiani” dedicati all’opera di Pier Paolo Pasolini). Oggetto della prolusione, il romanzo, « ritenuto responsabile di molte nefandezze». Il romanzo, considerato rivolto principalmente alle donne, «colpevole» fin da Dante con la storia d’amore di Paolo e Francesca e del libro di Lancillotto. Gli uomini non leggevano i romanzi e leggevano in latino. Nel Cinquecento, i romanzi cavallereschi spagnoli vennero vietati nelle Americhe perché avrebbero potuto “rovinare” gli indigeni, ritenuti esseri inferiori come del resto inferiori erano ritenute anche le donne. E fino al Settecento si fa della grande ironia sulle lettrici. Fino a Madame Bovary, uno dei primi romanzi processati per oscenità e adulterio. A metà Ottocento, cambiano un po’ le cose. Si comincia a pensare che una delle funzioni della letteratura sia andare a cercare le ombre delle cose. E’ l’epoca dello sviluppo dell’industria e della borghesia e cercare le ombre di quella società viene ritenuta una funzione utile. E si arriva all’oggi, alla predilezione per i romanzi d’evasione, alle “liale” contemporanee: libri scritti per commuovere o scanzonati. E anche sul fronte dell’impegno, ci si accontenta di un impegno minore rispetto a quello indicato da Sartre secondo cui la letteratura doveva intervenire e influire sul sociale. La rivoluzione non c’è più. Il leitmotiv è “sii te stesso”: è molto di moda e il romanzo viene confuso con il self-help. Nasce la romanzoterapia. I libri sono presentati come qualcosa che possa farti stare bene. Una volta, lo scrittore ringraziava chi lo aveva aiutato nel suo lavoro, oggi ringraziano il lettore per averlo accompagnato in un certo percorso. Il futuro? Passa attraverso la collaborazione con l’intelligenza artificiale. Già lo si fa. Sono molto interessato a capirne gli sviluppi, per quanto l’intelligenza artificiale possa fare paura. Si potrà arrivare a una letteratura impersonale, senza autori, come certi capolavori artistici dell’antichità. Non conosciamo i nomi degli scalpellini delle cattedrali o dei mosaicisti islamici»

A chiudere la giornata, l’etica e l’arte contemporanea con Nicolas Ballario (autore e conduttore di programmi sull’arte contemporanea; Paola Manfredi (fondatrice di un’agenzia di portata internazionale) e dell’artista bellanese Velasco Vitali.
Ballario ha sottolineato la difficoltà stessa nel definire l’arte contemporanea, nel rintracciarne le origini. Di fatto con le avanguardie novecentesche, con il futurismo stesso, l’arte comincia a sfidare il potere. Negli ultimi anni, invece, l’arte si è legata al potere finanziario, allontanandosi da quello politico e religioso. Gli artisti che vanno per la maggiore sono quelli che sfottono il potere, ma manche loro il legame con la sofferenza, il loro successo è determinato da poche persone: gli investitori, i grandi galleristi, in collezionisti ossessionati. E si allontana dal pubblico perché l’arte contemporanea non ha bisogno di un pubblico.

Un nome per tutti: Damien Hirst con, tra le opere, il suo squalo morto e conservato in formaldeide: «E’ un prodotto della mercificazione dell’arte – ha detto Manfredi -. L’arte è una merce come una merce è anche la morte. Ma gli artisti costituiscono una memoria storica e hanno la responsabilità del linguaggio che scelgono. Del resto, l’arte non è decorazione, non deve essere rassicurante.

Da parte sua, Velasco ha tributato un omaggio a Hirst, un autentico genio: «Lo squalo in formaldeide da solo lancia un messaggio che migliaia di attivisti ecologisti non riescono a fare. Perché quello squalo era già morto, sono tantissimi gli squali presi nelle reti dei pescatori. L’artista, se è responsabile, arriva a un momento in cui ritiene necessario cambiare il punto di vista, altrimenti ci limitiamo a bere quello che ci dicono.

I relatori non potevano certo trascurare la banana di Cattelan, «una sublimazione della presa in giro». «Gli artisti – le parole di Manfredi -, con la loro energia, trasformano la lettura del mondo. E’ successo sempre, non solo nell’arte contemporanea, è un codice per leggere la responsabilità del proprio tempo.» Perché l’arte – la conclusione di Velasco – è un linguaggio ricchissimo di significato.
I lavori sono stati aperti in mattinata dalla storica del design Domitilla Dardi con una relazione su “La rivoluzione del rammendo. La responsabilità di dar durare le cose”. Tema, i legami tra il design, la produzione industriali, il consumismo con i “bisogni indotti” dei consumatori. Delle responsabilità di ciascuno di questi soggetti in quella rincorsa alla novità che condiziona la vita quotidiana. Sottolineando come spesso per design si sia portati a pensare a oggetti se non di lusso quanto meno di una ricercatezza particolare destinata a un pubblico che se li può permettere, quando in realtà tutto quanto ci circonda è frutto di design.
Dardi ne ha raccontato l’evoluzione, gli approfondimenti di sociologhi, gli esperimenti spesso fallimentari di designer importanti a proposito di riutilizzo dei materiali, di riconversione di oggetti precedenti, di “rammendi” appunto. Un esempio che la dice lunga sulla nostra società è quello della bicicletta: è un prodotto che per materiali e componenti può durare 25 anni, ma in realtà negli Stati Uniti succede che viene utilizzato per soli due anni, dopo di che viene riciclata sui mercati del Paesi in via di sviluppo dove finisce per durare 75 anni. Evidentemente occorre un ripensamento che deve passare attraverso il rapporto diretto tra designer e utente.
E’ stata poi la volta di Giuseppe Patota e Valeria Della Valle, curatori del Dizionario della lingua italiana realizzato dalla Treccani. I due relatori si sono alternati al microfono nel raccontare la storia e l’evoluzione della lingua italiana attraverso un viaggio immaginario nel tempo e in giro per l’Italia: da Lecco ad Assisi dove nel 1224-25, san Francesco ha scritto il “cantico delle creature” che è il primo testo in volgare.
Dall’Umbria si risale a Firenze dove nel 1265 nacque Dante: la sua “Divina Commedia” è stata il nocciolo iniziale della lingua italiana. Da Firenze si sale a Venezia dove nel 1500 Pietro Bembo scrisse la prima grammatica italiana basandosi sui testi di Petrarca e Boccaccio, considerando quello di Dante un fiorentino contaminato da espressioni “basse”, popolari. E si ritorna di nuovo a Firenze dove un’accolita di buontemponi si trasformò per l’intervento di Luigi Salvati nell’Accademia della Crusca che nel 1612 pubblicò il primo Vocabolario della lingua italiana.
La tappa successiva è un ritorno a Lecco dove nell’Ottocento Alessandro Manzoni vi ambientò i suoi “Promessi sposi” in una lingua del quale non era contento, decidendo così di riportarci a Firenze per la famosa “risciacquatura” in Arno, per misurarsi cioè con il fiorentino parlato comunemente alla ricerca di una lingua che non fosse solo quella dei letterati ma comprensibile dai più. E con la successiva edizione del romanzo fondò praticamente l’Italiano moderno.
Successivamente, la linguista Beatrice Cristalli tracciato invece un’evoluzione storica della parola “responsabilità”, del concetto prima e del lemma poi. Partendo da Caino, quando a Dio risponde con quella fatidica domanda “Sono forse io il custode mio fratello” che in fondo altro non significa che negare ogni responsabilità nei confronti di Abele. In realtà, la parola “responsabilità” compare per la prima volta nel Settecento con le leggi della Repubblica Cisalpina per essere poi recepita nel 1876 dal Vocabolario del Tommaseo.
Andando oltre, Cristalli ha ricordato come la responsabilità abbia spesso un’accezione negativa, sottolineando peraltro come tutti la invochino ma generalmente nessuno se la vuole assumere. Per concludere ricordandone la concretezza, perché responsabilità – dal cui tronco fioriscano anche “sposi” – significa promessa e quindi impegno. La parola ha così la possibilità di creare essa stessa le cose. Responsabilità è una parola sociale ma che ha bisogno dell’agire e del fare.
Di “letteratura tra disimpegno e vocazione terapeutica” ha invece parlato Walter Siti, scrittore e critico letterario (curatore tra l’altro dei “Merdiani” dedicati all’opera di Pier Paolo Pasolini). Oggetto della prolusione, il romanzo, « ritenuto responsabile di molte nefandezze». Il romanzo, considerato rivolto principalmente alle donne, «colpevole» fin da Dante con la storia d’amore di Paolo e Francesca e del libro di Lancillotto. Gli uomini non leggevano i romanzi e leggevano in latino. Nel Cinquecento, i romanzi cavallereschi spagnoli vennero vietati nelle Americhe perché avrebbero potuto “rovinare” gli indigeni, ritenuti esseri inferiori come del resto inferiori erano ritenute anche le donne. E fino al Settecento si fa della grande ironia sulle lettrici. Fino a Madame Bovary, uno dei primi romanzi processati per oscenità e adulterio. A metà Ottocento, cambiano un po’ le cose. Si comincia a pensare che una delle funzioni della letteratura sia andare a cercare le ombre delle cose. E’ l’epoca dello sviluppo dell’industria e della borghesia e cercare le ombre di quella società viene ritenuta una funzione utile. E si arriva all’oggi, alla predilezione per i romanzi d’evasione, alle “liale” contemporanee: libri scritti per commuovere o scanzonati. E anche sul fronte dell’impegno, ci si accontenta di un impegno minore rispetto a quello indicato da Sartre secondo cui la letteratura doveva intervenire e influire sul sociale. La rivoluzione non c’è più. Il leitmotiv è “sii te stesso”: è molto di moda e il romanzo viene confuso con il self-help. Nasce la romanzoterapia. I libri sono presentati come qualcosa che possa farti stare bene. Una volta, lo scrittore ringraziava chi lo aveva aiutato nel suo lavoro, oggi ringraziano il lettore per averlo accompagnato in un certo percorso. Il futuro? Passa attraverso la collaborazione con l’intelligenza artificiale. Già lo si fa. Sono molto interessato a capirne gli sviluppi, per quanto l’intelligenza artificiale possa fare paura. Si potrà arrivare a una letteratura impersonale, senza autori, come certi capolavori artistici dell’antichità. Non conosciamo i nomi degli scalpellini delle cattedrali o dei mosaicisti islamici»
A chiudere la giornata, l’etica e l’arte contemporanea con Nicolas Ballario (autore e conduttore di programmi sull’arte contemporanea; Paola Manfredi (fondatrice di un’agenzia di portata internazionale) e dell’artista bellanese Velasco Vitali.
Ballario ha sottolineato la difficoltà stessa nel definire l’arte contemporanea, nel rintracciarne le origini. Di fatto con le avanguardie novecentesche, con il futurismo stesso, l’arte comincia a sfidare il potere. Negli ultimi anni, invece, l’arte si è legata al potere finanziario, allontanandosi da quello politico e religioso. Gli artisti che vanno per la maggiore sono quelli che sfottono il potere, ma manche loro il legame con la sofferenza, il loro successo è determinato da poche persone: gli investitori, i grandi galleristi, in collezionisti ossessionati. E si allontana dal pubblico perché l’arte contemporanea non ha bisogno di un pubblico.
Un nome per tutti: Damien Hirst con, tra le opere, il suo squalo morto e conservato in formaldeide: «E’ un prodotto della mercificazione dell’arte – ha detto Manfredi -. L’arte è una merce come una merce è anche la morte. Ma gli artisti costituiscono una memoria storica e hanno la responsabilità del linguaggio che scelgono. Del resto, l’arte non è decorazione, non deve essere rassicurante.
Da parte sua, Velasco ha tributato un omaggio a Hirst, un autentico genio: «Lo squalo in formaldeide da solo lancia un messaggio che migliaia di attivisti ecologisti non riescono a fare. Perché quello squalo era già morto, sono tantissimi gli squali presi nelle reti dei pescatori. L’artista, se è responsabile, arriva a un momento in cui ritiene necessario cambiare il punto di vista, altrimenti ci limitiamo a bere quello che ci dicono.
I relatori non potevano certo trascurare la banana di Cattelan, «una sublimazione della presa in giro». «Gli artisti – le parole di Manfredi -, con la loro energia, trasformano la lettura del mondo. E’ successo sempre, non solo nell’arte contemporanea, è un codice per leggere la responsabilità del proprio tempo.» Perché l’arte – la conclusione di Velasco – è un linguaggio ricchissimo di significato.
D.C.





















