Lecco: col filosofo Zygmunt Bauman riflessione sulla società attuale, “panico da migrazione” e assenza di prospettive certe
Grande attesa nel pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo, per Zygmunt Bauman, ospite d'onore della rassegna letteraria "Leggermente" organizzata da Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia in collaborazione con la Camera di Commercio, il Comune e la Provincia.
Il famoso sociologo e filosofo polacco di origini ebraiche, teorico della definizione di "modernità liquida" è intervenuto al Teatro della Società di Lecco per presentare insieme al coautore Carlo Bordoni il libro "Stato di crisi", pubblicato in inglese nel 2013 ed edito da Einaudi nel 2015.
Ed ecco riaffiorare la paura irrazionale di ciò che è sconosciuto e senza nome: "le grandi migrazioni di ogni genere e direzione sono sempre esistite e hanno rappresentato momenti di crescita. Il filo rosso della paura riemerge qui legato ad altri fenomeni sociali, come la recrudescenza del terrorismo che dimostra come la modernità non sia più in grado di gestire l'aspetto irrazionale di questo sentimento".
L'esempio presentato da Bauman è quello del premier ungherese Viktor Orban, che si è lanciato nella costruzione di un muro a protezione dei confini, registrando un aumento del favore tra gli elettori; anche altri Paesi generalmente più tolleranti si stanno allineando a questa tendenza "da tenere sotto controllo. Bisogna ricordate che in Inghilterra l'arrivo di immigrati costretti a lasciare il proprio Paese d'origine ha avuto effetti decisamente positivi sul PIL e che nonostante la politica rigida degli Stati Uniti contro l'immigrazione messicana, molte imprese californiane faticano ad andare avanti senza quella forza lavoro". Riguardo gli attentati di Parigi, il sociologo ha sottolineato la necessità di cogliere complessivamente tutte le dinamiche dell'immigrazione, anche quelle nascoste sotto la superficie: "solo due dei responsabili provenivano dall'estero, mentre gli altri erano nati in Francia ma, reduci da un processo di integrazione fallimentare e dall'assenza di una prospettiva di vita dignitosa, hanno deciso di guadagnare importanza con un gesto tragico, estremo".
Il famoso sociologo e filosofo polacco di origini ebraiche, teorico della definizione di "modernità liquida" è intervenuto al Teatro della Società di Lecco per presentare insieme al coautore Carlo Bordoni il libro "Stato di crisi", pubblicato in inglese nel 2013 ed edito da Einaudi nel 2015.

Zygmunt Bauman e Carlo Bordoni
Più che di questo ultimo volume, l'illustre pensatore però ha preferito parlare dell'opera su cui sta lavorando al momento, incentrata sul tema della migrazione. A introdurre l'argomento è stato proprio il professor Bordoni, sociologo, giornalista e saggista nonché collaboratore del Corriere della Sera, che partendo dalle riflessioni note di Bauman sulla modernità ha tracciato l'evoluzione del concetto di "paura" fino al Novecento per contestualizzare il timore verso il fenomeno migratorio. "E' il sentimento più antico del mondo e ha accompagnato l'uomo fin dalle origini, ma nel tempo si è trasformato. Nella Grecia classica per riferirsi alla paura venivano utilizzati due termini distinti, Phobos e Deimos: uno indicava il sentimento cieco e irrazionale nei confronti dell'ignoto, l'altro il sentire consapevole di ciò che conosciamo, quindi controllabile con la razionalità". Con l'avvento della modernità - ha proseguito il professor Bordoni - l'accezione di Phobos è stata rimossa, perché dominare il mondo significa dominare la paura, nascondendo i timori irrazionali in nome del controllo della ragione. Tre eventi determinanti hanno caratterizzato la nascita della modernità: la rivoluzione industriale, che ha portato l'etica del lavoro e il dominio del progresso sulla natura; la nascita dello Stato, che ha permesso di creare una condizione di sicurezza all'interno dei confini; l'Illuminismo, che ha sancito un sistema di conoscenze basato non sui dogmi religiosi ma sulla razionalità. Tuttavia intorno alla metà del Novecento il crollo di questi tre pilastri della modernità ha rimescolato nuovamente le carte in tavola, mettendo in discussione gli effetti positivi del progresso, la funzionalità dello Stato sovrano e la sclerosi della razionalità, degenerata nel controllo assoluto della persona negli Stati totalitari.
Ed ecco riaffiorare la paura irrazionale di ciò che è sconosciuto e senza nome: "le grandi migrazioni di ogni genere e direzione sono sempre esistite e hanno rappresentato momenti di crescita. Il filo rosso della paura riemerge qui legato ad altri fenomeni sociali, come la recrudescenza del terrorismo che dimostra come la modernità non sia più in grado di gestire l'aspetto irrazionale di questo sentimento".

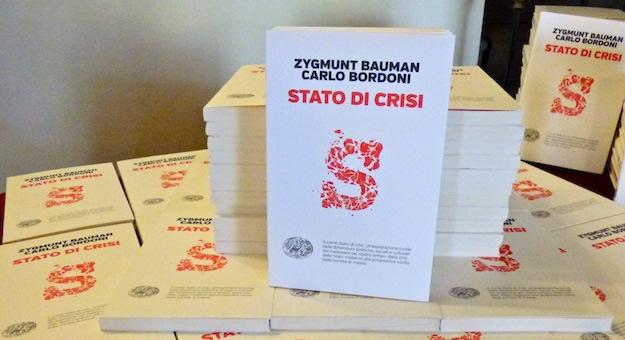

L'esempio presentato da Bauman è quello del premier ungherese Viktor Orban, che si è lanciato nella costruzione di un muro a protezione dei confini, registrando un aumento del favore tra gli elettori; anche altri Paesi generalmente più tolleranti si stanno allineando a questa tendenza "da tenere sotto controllo. Bisogna ricordate che in Inghilterra l'arrivo di immigrati costretti a lasciare il proprio Paese d'origine ha avuto effetti decisamente positivi sul PIL e che nonostante la politica rigida degli Stati Uniti contro l'immigrazione messicana, molte imprese californiane faticano ad andare avanti senza quella forza lavoro". Riguardo gli attentati di Parigi, il sociologo ha sottolineato la necessità di cogliere complessivamente tutte le dinamiche dell'immigrazione, anche quelle nascoste sotto la superficie: "solo due dei responsabili provenivano dall'estero, mentre gli altri erano nati in Francia ma, reduci da un processo di integrazione fallimentare e dall'assenza di una prospettiva di vita dignitosa, hanno deciso di guadagnare importanza con un gesto tragico, estremo".

In prima fila Giovanni Priore (Acel Lecco), Simona Piazza (assessore alla Cultura),
il sindaco Virginio Brivio, Peppino Ciresa (Confcommercio)
E.T.















