Lecco: dal Fascismo alla democrazia, nella tesi di Butti il 'respiro' di una città
Un periodo di frenesia e caos istituzionale, di fratture e continuità: il passaggio dalla Repubblica Sociale all’Italia democratica sancito dalla fatidica data della Liberazione (il 25 aprile a Milano, il 27 nella nostra città) ma con un prima e con un dopo, così com’è testimoniato dai documenti amministrativi, in particolare quelli conservati negli archivi del Comune di Lecco.
Era l’argomento scelto per la tesi di laurea in scienze politiche di Marcello Butti, ora docente e assessore comunale a Valmadrera. Ed è stato il tema di un incontro tenutosi nei giorni scorsi alla Biblioteca civica “Pozzoli” di Lecco. Insieme a Butti anche lo storico lecchese Angelo De Battista. Appunto “Dalla Repubblica Sociale alla Repubblica parlamentare” il titolo, che racchiude quanto avvenuto tra il 1943 e il 1946. «Un periodo di frenesia e caos istituzionale», come ha detto l'autore, in cui a livello nazionale si sono avvicendati quattro governi: quello fascista di Benito Mussolino, quello del maresciallo Pietro Badoglio dopo il 25 luglio, la mussoliniana Repubblica Sociale nel Nord e Centro Italia dopo l’8 settembre con l’occupazione tedesca e infine le istituzioni democratiche all’indomani della Liberazione. Mentre a Lecco, in un periodo di 18 mesi, si sono alternati ben cinque commissari prefettizi.

Un periodo letto attraverso una serie di documenti dai risvolti tragici, ma in alcuni casi anche comici come quando, il 2 ottobre 1943, il prefetto nominò commissario l’architetto Mario Cereghini. Solo che in quei giorni lui e la famiglia non erano in città ma all’Aprica e la lettera di nomina non lo raggiunse. Fu quindi necessario convocare un altro al suo posto. Da parte sua, Cereghini seppe della cosa da quei giornali che pure affermava di non voler leggere perché pieni di nefandezze e scrisse al prefetto una lettera risentita per non essere stato nemmeno consultato.

Butti e De Battista si sono alternati nell’approfondire alcuni aspetti della tesi dell’assessore valmadrerese che al momento della stesura si era rivolto proprio all’Anpi per individuare un argomento che non fosse ancora stato sviscerato fino in fondo, quale appunto quel periodo di storia lecchese attraverso la lente dei documenti ufficiali del municipio e non quindi la riproposizione di temi strettamente legati alla lotta di liberazione.
Un periodo – è stato detto – caratterizzato appunto da fratture ma anche da una forte continuità con quello fascista. Da un lato, le alte cariche cedevano il passo a volti nuovi, dall’altro i ranghi inferiori della pubblica amministrazione rimanevano al loro posto per i motivi più differenti, ma soprattutto per la necessità di dover continuare a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza. E le carte emerse dagli archivi evidenziano tutte le difficoltà di quei mesi: un corpo di vigili urbani con un organico di 26 persone anche se in realtà nove non rispondevano all’appello, perché sei erano in servizio militare e tre chissà dove. E intanto l’Economato metteva nero su bianco che per approvvigionarsi della carta necessaria al regolare lavoro d’ufficio si autorizzava l’acquisto sul mercato nero. Semmai a sconcertare – ha sottolineato De Battista – non è tanto la continuità di quei mesi quanto quella successiva, se si pensa che per l’85% i prefetti in carica in Italia erano ancora di nomina fascista.
Ci si è soffermati poi sulla “questione” del consenso ottenuto dal Fascismo da parte del popolo italiano. Una “questione” sulla quale gli storici ancora discutono. Perché dalla narrazione dei primissimi anni del dopoguerra che presentava un’Italia sostanzialmente avversa si è passati, in particolare con gli studi di Renzo De Felice, al racconto di un alto consenso popolare soprattutto negli anni Trenta, quelli dell’Impero, della “conquista” dell’Etiopia. Per tornare oggi a una ulteriore riflessione sulla reale adesione degli italiani al Fascismo: «Difficile valutare, sono tutte congetture…».
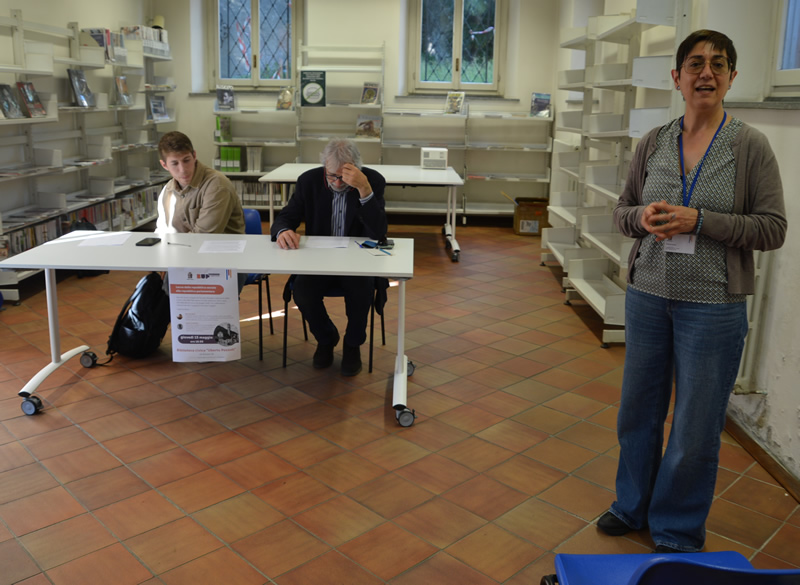
Di sicuro, però, proprio a proposito di consenso, ci sono differenze sostanziali tra il periodo fascista vero e proprio e quello della Repubblica Sociale, quando la popolazione da tre anni faceva i conti con le sofferenze della guerra, con i propri cari morti al fronte o comunque in servizio militare, con la penuria alimentare aggravata dalle requisizioni operate dai tedeschi che occupavano buona parte del Paese. Segnali che si leggono anche nella storia lecchese: gli scioperi, il numero di renitenti alla leva, la costituzione del Cln (Comitato di liberazione nazionale) che testimonia un risveglio delle coscienze perché, nonostante la censura della stampa di regime, le notizie circolavano.
E certi dati sono emblematici. Quando, all’indomani dell’8 settembre, venne pubblicato l’avviso agli “sbandati” (i soldati dell’Esercito italiani rimasti appunto senza guida) di presentarsi al più vicino Comando tedesco, nessuno si fece vivo ai presidi della Wermacht, mentre solo poco più di trecento comunicarono la propria presenza ai Comuni di residenza, ma anche di questa frangia molti poi si eclissarono. Situazione analoga a quella di renitenti e cioè dei giovani in età di coscrizione ma che rifiutarono di indossare la divisa di Salò. Scelte non solo personali – è stato detto – ma sostenute dal consenso dei loro cari. «Il primo atto della Resistenza, quindi, fu un atto di disobbedienza». Così che nel gennaio 1944 le autorità nazifasciste minacciarono proprio rappresaglie sui famigliari. Ed è motivo per cui un dirigente della Provincia in una lettera invitava a non eccedere con la repressione per evitare che gli sbandati si trasformassero, da una massa che viveva nell’ombra, in una forza di sostegno dei partigiani. Che nel 1944 ingrossarono le fila. Anzi, si fu costretti a rifiutare molti nuovi arrivi, perché gli spazi per ospitarli non erano sufficienti come non lo erano cibo e vestiario. Nello spiegare il proprio suggerimento, lo stesso dirigente provinciale sottolineava come ormai il popolo fosse nella quasi totalità antifascista o tutt’al più apatico e fosse quindi necessaria molta cautela per evitare una frattura tra Rsi e popolo. E quindi fosse opportuno colpire solo chi era davvero ostile.

Poi, arrivò la Liberazione, «ma il mondo non finiva». Il Cln, con la ratifica degli alleati angloamericani, nominò sindaco della città Giuseppe Mauri. Le preoccupazioni di quei giorni sono presto dette: mantenere i rapporti con gli stessi alleati che di fatto sono la nuova forza di occupazione del territorio (tanto che il 4 luglio a Lecco si festeggia l’Independence Day), con il Cln e le diverse anime politiche, ma soprattutto affrontare le difficoltà alimentari della popolazione che dovrà usare la tessera annonaria fino al 1947. C’è poi l’aspetto della sicurezza che fino al 30 maggio 1945 contava ancora sui partigiani: circa trecento persone in armi invitate a dar man forte ai carabinieri e a continuare a ricercare i soldati tedeschi che non erano ancora riusciti a trovare la via di casa. Dopodiché, scattò l’ordine di riconsegnare le armi perché a quel punto gli alleati cominciarono a temere che i partigiani armati si trasformassero in rivoluzionari.
Intanto si cambiarono anche i nomi alle strade cancellando la toponomastica fascista, ma si doveva anche pensare ai lavori pubblici per quanto non ci fossero soldi e le proprietà fossero appunto quelle alimentari. Tanto che Mauri commentava: «Sono tacciato di nullismo, ma se nullismo vuol dire dar da mangiare alla popolazione va bene così…».

Altro problema non secondario, quello del lavoro con la sigla, per certi versi clamorosa, di un accordo sindacale per il licenziamento dalle fabbriche degli sfollati per consentire il reintegro di chi tornava dal fronte o dai lager. «Avevamo imparato la lezione del 1918 – avrebbe commentato il segretario della Camera del lavoro Gabriele Invernizzi -, quando i reduci si trovarono ai margini della società e andarono a ingrossare le fila dello squadrismo».
Si arrivò infine alle elezioni del marzo 1946, le prime democratiche, quando per la prima volta si recarono alle urne anche le donne, circa tre mesi prima del referendum su Repubblica e Monarchia. Al voto il 90% della popolazione. A Lecco la Dc guidata da Ugo Bartesaghi fu il primo partito con 17 seggi , seguirono il Psi di Giuseppe Mauri con 12 e il Pci di Gabriele Invernizzi con 9. Due le donne elette: Maria Panzeri (la vedova di Uberto Pozzoli) per la Dc ed Enrica Bonazzi Canepa per il Pci.
Psi e Mauri avrebbero voluto proseguire l’esperienza unitaria dei mesi precedenti, ma la Dc non era d’accordo su una ripartizione paritaria degli incarichi di giunta (tre per partito). Si formò così una giunta socialcomunista, preludio di quel Fronte Popolare che si formerà per le elezioni politiche del 1948. Quando Giuseppe Mauri si dimise dopo che l’elettorato italiano e lecchese scelse in massa la Dc.
Era l’argomento scelto per la tesi di laurea in scienze politiche di Marcello Butti, ora docente e assessore comunale a Valmadrera. Ed è stato il tema di un incontro tenutosi nei giorni scorsi alla Biblioteca civica “Pozzoli” di Lecco. Insieme a Butti anche lo storico lecchese Angelo De Battista. Appunto “Dalla Repubblica Sociale alla Repubblica parlamentare” il titolo, che racchiude quanto avvenuto tra il 1943 e il 1946. «Un periodo di frenesia e caos istituzionale», come ha detto l'autore, in cui a livello nazionale si sono avvicendati quattro governi: quello fascista di Benito Mussolino, quello del maresciallo Pietro Badoglio dopo il 25 luglio, la mussoliniana Repubblica Sociale nel Nord e Centro Italia dopo l’8 settembre con l’occupazione tedesca e infine le istituzioni democratiche all’indomani della Liberazione. Mentre a Lecco, in un periodo di 18 mesi, si sono alternati ben cinque commissari prefettizi.

Marcello Butti
Un periodo letto attraverso una serie di documenti dai risvolti tragici, ma in alcuni casi anche comici come quando, il 2 ottobre 1943, il prefetto nominò commissario l’architetto Mario Cereghini. Solo che in quei giorni lui e la famiglia non erano in città ma all’Aprica e la lettera di nomina non lo raggiunse. Fu quindi necessario convocare un altro al suo posto. Da parte sua, Cereghini seppe della cosa da quei giornali che pure affermava di non voler leggere perché pieni di nefandezze e scrisse al prefetto una lettera risentita per non essere stato nemmeno consultato.

Angelo De Battista
Butti e De Battista si sono alternati nell’approfondire alcuni aspetti della tesi dell’assessore valmadrerese che al momento della stesura si era rivolto proprio all’Anpi per individuare un argomento che non fosse ancora stato sviscerato fino in fondo, quale appunto quel periodo di storia lecchese attraverso la lente dei documenti ufficiali del municipio e non quindi la riproposizione di temi strettamente legati alla lotta di liberazione.
Un periodo – è stato detto – caratterizzato appunto da fratture ma anche da una forte continuità con quello fascista. Da un lato, le alte cariche cedevano il passo a volti nuovi, dall’altro i ranghi inferiori della pubblica amministrazione rimanevano al loro posto per i motivi più differenti, ma soprattutto per la necessità di dover continuare a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza. E le carte emerse dagli archivi evidenziano tutte le difficoltà di quei mesi: un corpo di vigili urbani con un organico di 26 persone anche se in realtà nove non rispondevano all’appello, perché sei erano in servizio militare e tre chissà dove. E intanto l’Economato metteva nero su bianco che per approvvigionarsi della carta necessaria al regolare lavoro d’ufficio si autorizzava l’acquisto sul mercato nero. Semmai a sconcertare – ha sottolineato De Battista – non è tanto la continuità di quei mesi quanto quella successiva, se si pensa che per l’85% i prefetti in carica in Italia erano ancora di nomina fascista.
Ci si è soffermati poi sulla “questione” del consenso ottenuto dal Fascismo da parte del popolo italiano. Una “questione” sulla quale gli storici ancora discutono. Perché dalla narrazione dei primissimi anni del dopoguerra che presentava un’Italia sostanzialmente avversa si è passati, in particolare con gli studi di Renzo De Felice, al racconto di un alto consenso popolare soprattutto negli anni Trenta, quelli dell’Impero, della “conquista” dell’Etiopia. Per tornare oggi a una ulteriore riflessione sulla reale adesione degli italiani al Fascismo: «Difficile valutare, sono tutte congetture…».
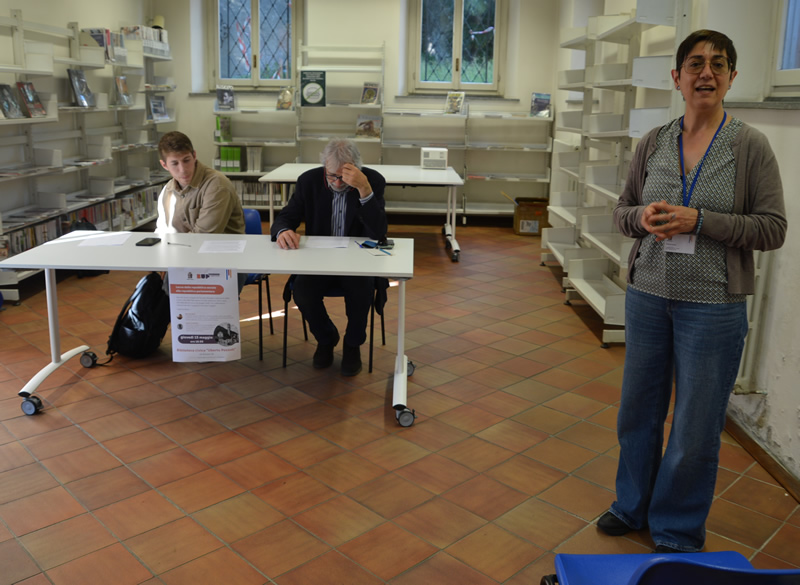
Di sicuro, però, proprio a proposito di consenso, ci sono differenze sostanziali tra il periodo fascista vero e proprio e quello della Repubblica Sociale, quando la popolazione da tre anni faceva i conti con le sofferenze della guerra, con i propri cari morti al fronte o comunque in servizio militare, con la penuria alimentare aggravata dalle requisizioni operate dai tedeschi che occupavano buona parte del Paese. Segnali che si leggono anche nella storia lecchese: gli scioperi, il numero di renitenti alla leva, la costituzione del Cln (Comitato di liberazione nazionale) che testimonia un risveglio delle coscienze perché, nonostante la censura della stampa di regime, le notizie circolavano.
E certi dati sono emblematici. Quando, all’indomani dell’8 settembre, venne pubblicato l’avviso agli “sbandati” (i soldati dell’Esercito italiani rimasti appunto senza guida) di presentarsi al più vicino Comando tedesco, nessuno si fece vivo ai presidi della Wermacht, mentre solo poco più di trecento comunicarono la propria presenza ai Comuni di residenza, ma anche di questa frangia molti poi si eclissarono. Situazione analoga a quella di renitenti e cioè dei giovani in età di coscrizione ma che rifiutarono di indossare la divisa di Salò. Scelte non solo personali – è stato detto – ma sostenute dal consenso dei loro cari. «Il primo atto della Resistenza, quindi, fu un atto di disobbedienza». Così che nel gennaio 1944 le autorità nazifasciste minacciarono proprio rappresaglie sui famigliari. Ed è motivo per cui un dirigente della Provincia in una lettera invitava a non eccedere con la repressione per evitare che gli sbandati si trasformassero, da una massa che viveva nell’ombra, in una forza di sostegno dei partigiani. Che nel 1944 ingrossarono le fila. Anzi, si fu costretti a rifiutare molti nuovi arrivi, perché gli spazi per ospitarli non erano sufficienti come non lo erano cibo e vestiario. Nello spiegare il proprio suggerimento, lo stesso dirigente provinciale sottolineava come ormai il popolo fosse nella quasi totalità antifascista o tutt’al più apatico e fosse quindi necessaria molta cautela per evitare una frattura tra Rsi e popolo. E quindi fosse opportuno colpire solo chi era davvero ostile.

Poi, arrivò la Liberazione, «ma il mondo non finiva». Il Cln, con la ratifica degli alleati angloamericani, nominò sindaco della città Giuseppe Mauri. Le preoccupazioni di quei giorni sono presto dette: mantenere i rapporti con gli stessi alleati che di fatto sono la nuova forza di occupazione del territorio (tanto che il 4 luglio a Lecco si festeggia l’Independence Day), con il Cln e le diverse anime politiche, ma soprattutto affrontare le difficoltà alimentari della popolazione che dovrà usare la tessera annonaria fino al 1947. C’è poi l’aspetto della sicurezza che fino al 30 maggio 1945 contava ancora sui partigiani: circa trecento persone in armi invitate a dar man forte ai carabinieri e a continuare a ricercare i soldati tedeschi che non erano ancora riusciti a trovare la via di casa. Dopodiché, scattò l’ordine di riconsegnare le armi perché a quel punto gli alleati cominciarono a temere che i partigiani armati si trasformassero in rivoluzionari.
Intanto si cambiarono anche i nomi alle strade cancellando la toponomastica fascista, ma si doveva anche pensare ai lavori pubblici per quanto non ci fossero soldi e le proprietà fossero appunto quelle alimentari. Tanto che Mauri commentava: «Sono tacciato di nullismo, ma se nullismo vuol dire dar da mangiare alla popolazione va bene così…».

Altro problema non secondario, quello del lavoro con la sigla, per certi versi clamorosa, di un accordo sindacale per il licenziamento dalle fabbriche degli sfollati per consentire il reintegro di chi tornava dal fronte o dai lager. «Avevamo imparato la lezione del 1918 – avrebbe commentato il segretario della Camera del lavoro Gabriele Invernizzi -, quando i reduci si trovarono ai margini della società e andarono a ingrossare le fila dello squadrismo».
Si arrivò infine alle elezioni del marzo 1946, le prime democratiche, quando per la prima volta si recarono alle urne anche le donne, circa tre mesi prima del referendum su Repubblica e Monarchia. Al voto il 90% della popolazione. A Lecco la Dc guidata da Ugo Bartesaghi fu il primo partito con 17 seggi , seguirono il Psi di Giuseppe Mauri con 12 e il Pci di Gabriele Invernizzi con 9. Due le donne elette: Maria Panzeri (la vedova di Uberto Pozzoli) per la Dc ed Enrica Bonazzi Canepa per il Pci.
Psi e Mauri avrebbero voluto proseguire l’esperienza unitaria dei mesi precedenti, ma la Dc non era d’accordo su una ripartizione paritaria degli incarichi di giunta (tre per partito). Si formò così una giunta socialcomunista, preludio di quel Fronte Popolare che si formerà per le elezioni politiche del 1948. Quando Giuseppe Mauri si dimise dopo che l’elettorato italiano e lecchese scelse in massa la Dc.
D.C.





















