Le città si salveranno solo con la collaborazione di tutti. Riflessioni sull'urbanistica
Partire dalla bellezza, nelle sue declinazioni differenti. Coinvolgere tutti nelle scelte affinché tutti se ne sentano responsabili. Accettare i cambiamenti ma saper guidare il nuovo che avanza. Saper fare scelte strategiche. Scelte che siano culturali e non ideologiche.

Dopo l’inverno demografico, è stata l’urbanistica il nuovo tema di confronto proposto da “Appello per Lecco”, “Azione”, “Gruppo per Lecco” e “Insieme” in un incontro tenutosi ieri sera all’Ostello di San Giovanni. Sono i giorni, questi, in cui si presentano le osservazioni al Piano di governo del territorio – lo strumento con il quale il Comune disegna appunto lo sviluppo urbanistico di Lecco – ma la serata non ha affrontato espressamente i problemi e le sfide di una città che ancora sta cambiando, dopo la “rivoluzione” di ormai quarant’anni fa con la deindustrializzazione che ha lasciato molti interrogativi ai quali ancora non si è riusciti a dare risposte. Solo da parte del pubblico qualche dito è stato messo nella piaga: i costi delle abitazioni, il rischio che il turismo finisca con l’opprimere i residenti…
Si è trattato, in effetti, di una discussione sulle idee guida per una progettazione urbanistica che punti al bene comune, al bene di tutti e non agli interessi particolari, alla comunità e non all’individualismo. Che è – lo sa chi ha qualche capello bianco – quel “nodo” quasi eterno che in alcuni momenti sembra essere se non proprio sciolto almeno più lasco e in altri torna invece a stringersi.
Introdotti dall’ex sindaco lecchese Virginio Brivio, sono intervenuti Anna Schellino, docente al Politecnico; Gianni Verga a lungo consigliere regionale lombardo, padre di quella legge (appunto ricordata come legge Verga) che nel 1986 diede una svolta all’urbanistica lombarda, spingendo verso il recupero del patrimonio edilizio già esistente evitando un ulteriore consumo di suolo; Ippolita Chiarolini, ingegnere che per il suo ordine professionale si occupa degli aspetti legali della collaborazione fra pubblico e privato.

Aprendo l’incontro, Brivio ha posto sul tavolo il tema della riflessione cruciale chiedendosi se, quando si parla di «una città per tutti» occorra mettere alla fine un bel punto interrogativo. Perché sviluppo e governo del territorio non significa solo condizioni edilizie, urbanistiche e infrastrutture, ma occorre andare oltre: un’urbanistica al servizio di tutti è saper leggere le distanze tra chi sta bene e chi sta male, tra pubblico e privato, tra i mercati, tra i quartieri.

Proprio per questo, Schellino ha indicato subito come orizzonte al quale guardare quello della bellezza, parola che è poi ricorsa più volte e alla quale hanno fatto riferimento anche gli altri relatori.
Schellino ha parlato della necessità di coprogrammazione, coprogettazione, coproduzione: devono nuovi metodi di lavoro, coinvolgendo il più alto numero di persone, dai bambini agli anziani, e di associazioni le più diverse non solo raccogliendone le esigenze ma anche le proposte di soluzione e insieme elaborare i progetti. Per fare ciò è importante una comunicazione efficace, accessibile ai più e trasversale. Ed è altrettanto importante da parte degli amministratori restituire ai cittadini risultati ed esiti di monitoraggi e indagini. Così che tutti siano responsabili del bene comune, garantendo a tutti di essere davvero cittadini attivi e non con iniziative di sola facciata. Bisogna educare ad andare oltre, perché le barriere culturali sono le più difficili da superare. Bisogna mettere la persona al centro perché ogni individuo è una ricchezza.
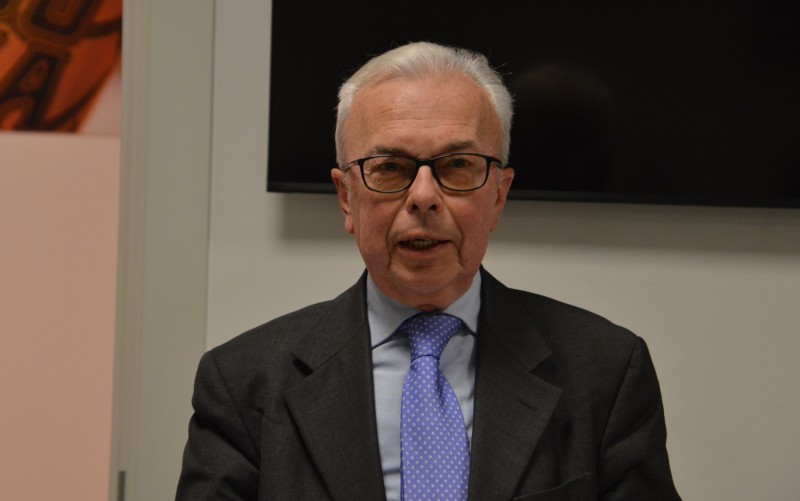
Da parte sua, Verga ha risposto a una sollecitazione di Brivio - che lui ha detto di voler continuare a chiamare sindaco (con gli inevitabili sorrisi in sala: «Mai dire mai») - sulla differenza tra quel che oggi si chiama rigenerazione e un tempo cambio di destinazione d’uso: «Rigenerazione è soltanto una parola di moda. Quando quarant’anni fa proposi la mia legge si parlava di programmi integrati di intervento, poi di piani di ristrutturazione urbanistica e poi in altro modo ancora. Perché le città per continuare a essere città devono cambiare continuamente, sono il luogo del cambiamento per eccellenza, tutto il nuovo arriva dalle città, sia il bello che il brutto».
E, a proposito di bellezza, ha citato il cardinale Carlo Maria Martini: nel 1999 guardò al terzo millennio e al tema della bellezza ricordando il Dostoevskij della “bellezza che salverà il mondo”, ma si è chiesto “Quale bellezza?”. Solo la bellezza che si coniuga col bene. Lo sapeva già Francesco Sforza che cinquecento anni prima ordinò all’archistar dell’epoca, il Filarete, di progettare un grande ospedale che, tra le altre cose, fosse bello perché la bellezza aiuta a stare bene. Perché la bellezza, se c’è il bene, è il benessere delle città. Quella città viste come demoni e che sono il vero tema della politica del territorio. Al mondo, la metà della popolazione vive nelle città. E il fenomeno crescerà ancora di più. E Martini diceva che la città è il luogo dove si incontra la tolleranza.

Verga ha sottolineato come davvero il governo del territorio riguardi tutti perché l’urbanistica è la più alta concezione della politica, perché significa creare le condizioni di vita di una comunità. Un piano di governo del territorio può essere espressione di un’ideologia e quindi imponendo regole rigide o di una cultura e perciò tenendo conto del vissuto dell’intera società. Cinquant’anni fa c’era l’ideologia che le città dovessero diventare quelle cose schematiche che qualcuno diceva dovevano essere. Questo schema è saltato. Proprio qui. In Lombardia. Perché la nostra società lombarda ha una forza di propulsione dal basso incredibile. Nelle emergenze è la società che arriva prima. In un’alluvione, prima delle istituzioni arriva il vicino di cosa. E allora la logica è semplice. Il nuovo è ineluttabile e va guidato, esercitando la libertà responsabile e non le anarchie e cioè non faccio quel che voglio ma ciò che è utile, ciò che serve. E con un piano di governo del territorio la rigenerazione si può fare, anche se le regole dovrebbero essere più semplici perché in Italia abbiamo leggi che si contraddicono tra loro: sono state fatte leggi nuove senza abrogare quelle vecchie. Abbiamo bisogno di vivere e praticare un principio della nostra Costituzione, quello della sussidiarietà, un rapporto leale tra pubblico e privato. Pensando a ciò che già cinquant’anni fa diceva il primo presidente regionale Piero Bassetti che era avanti a tutti e cioè che il territorio è glocale. E oggi ce ne rendiamo conto. Nel proprio sistema locale ognuno è sicuro, è una comunità, mentre nell’individualismo c’è solo insicurezza.
A chi gli ha chiesto quale fosse l’ideologia dominante di oggi, Verga ha risposto indicando la finanza che va contrastata in ogni modo per ritornare alla cultura del lavoro.
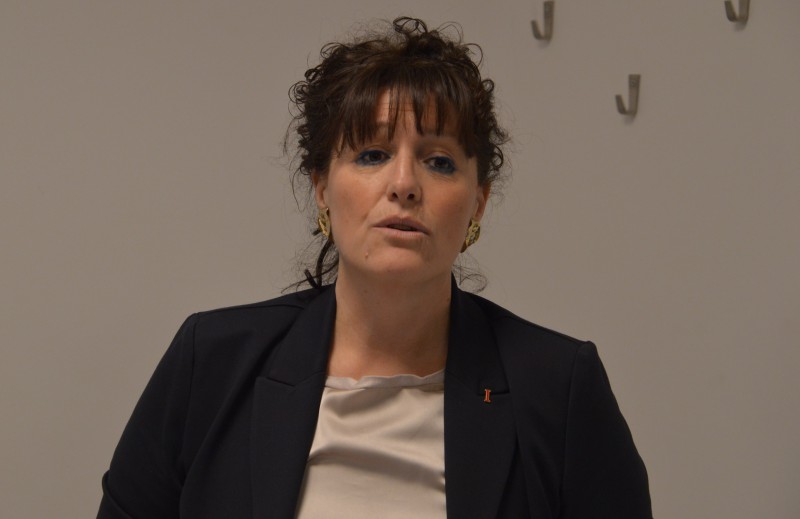
Più tecnico l’intervento di Chiarolini concentrato proprio sul rapporto tra pubblico e privato. Ha illustrato le varie forme di possibile collaborazione tra finanza di progetto o leasing, ma ricordando come in ogni caso vadano previsti gli scenari del futuro, le scelte debbano essere accompagnate da rigorosi ragionamenti economici e sociali, il contraddittorio tra enti pubblici e società private debba essere aperto, gli sguardi convergenti, la collaborazione equilibrata, la necessità che ciascuno rispetti il proprio ruolo. Altrimenti, si rischia il fallimento. Occorre quindi confrontarsi sulle strategie: saper scegliere se un progetto sia giusto farlo in un luogo anziché in un altro non solo per il desiderio di un sindaco, di un assessore, di un imprenditore privato, ma tenendo conto delle condizioni oggettive anche di mercato. Considerazioni forse banali ma che vengono spesso trascurate.
Ha poi indicato le buone regole a cui gli amministratori dovrebbero attenersi: la lungimiranza, i trasferimenti del rischio, tener conto della sostenibilità economica e finanziaria del progetto, non si può andare all’arrembaggio e non solo gli enti pubblici ma anche i privati. Vero è che, oltre alle leggi che si sovrappongono, in Italia vi è anche un’eccessiva incertezza sui tempi che fa fuggire gli investitori. Concludendo quasi con una contraddizione: perché se ha parlato dell’’individualismo imperante di oggi che ha frammentato le comunità, anzi che le comunità non esistono proprio più, nel contempo ha contrapposto le caverne preistoriche alla competizione perché dove c’è competizione c’è civiltà. Spiegando che la competizione leale è un bene per tutti.
L’assemblea si è sciolta con una battuta di Brivio: «L’ostello in cui siamo è sorto dove c’era un vecchio cimitero. Più rigenerazione di così. Una risurrezione».
Dopo l’inverno demografico, è stata l’urbanistica il nuovo tema di confronto proposto da “Appello per Lecco”, “Azione”, “Gruppo per Lecco” e “Insieme” in un incontro tenutosi ieri sera all’Ostello di San Giovanni. Sono i giorni, questi, in cui si presentano le osservazioni al Piano di governo del territorio – lo strumento con il quale il Comune disegna appunto lo sviluppo urbanistico di Lecco – ma la serata non ha affrontato espressamente i problemi e le sfide di una città che ancora sta cambiando, dopo la “rivoluzione” di ormai quarant’anni fa con la deindustrializzazione che ha lasciato molti interrogativi ai quali ancora non si è riusciti a dare risposte. Solo da parte del pubblico qualche dito è stato messo nella piaga: i costi delle abitazioni, il rischio che il turismo finisca con l’opprimere i residenti…
Si è trattato, in effetti, di una discussione sulle idee guida per una progettazione urbanistica che punti al bene comune, al bene di tutti e non agli interessi particolari, alla comunità e non all’individualismo. Che è – lo sa chi ha qualche capello bianco – quel “nodo” quasi eterno che in alcuni momenti sembra essere se non proprio sciolto almeno più lasco e in altri torna invece a stringersi.
Introdotti dall’ex sindaco lecchese Virginio Brivio, sono intervenuti Anna Schellino, docente al Politecnico; Gianni Verga a lungo consigliere regionale lombardo, padre di quella legge (appunto ricordata come legge Verga) che nel 1986 diede una svolta all’urbanistica lombarda, spingendo verso il recupero del patrimonio edilizio già esistente evitando un ulteriore consumo di suolo; Ippolita Chiarolini, ingegnere che per il suo ordine professionale si occupa degli aspetti legali della collaborazione fra pubblico e privato.
Aprendo l’incontro, Brivio ha posto sul tavolo il tema della riflessione cruciale chiedendosi se, quando si parla di «una città per tutti» occorra mettere alla fine un bel punto interrogativo. Perché sviluppo e governo del territorio non significa solo condizioni edilizie, urbanistiche e infrastrutture, ma occorre andare oltre: un’urbanistica al servizio di tutti è saper leggere le distanze tra chi sta bene e chi sta male, tra pubblico e privato, tra i mercati, tra i quartieri.
Proprio per questo, Schellino ha indicato subito come orizzonte al quale guardare quello della bellezza, parola che è poi ricorsa più volte e alla quale hanno fatto riferimento anche gli altri relatori.
Schellino ha parlato della necessità di coprogrammazione, coprogettazione, coproduzione: devono nuovi metodi di lavoro, coinvolgendo il più alto numero di persone, dai bambini agli anziani, e di associazioni le più diverse non solo raccogliendone le esigenze ma anche le proposte di soluzione e insieme elaborare i progetti. Per fare ciò è importante una comunicazione efficace, accessibile ai più e trasversale. Ed è altrettanto importante da parte degli amministratori restituire ai cittadini risultati ed esiti di monitoraggi e indagini. Così che tutti siano responsabili del bene comune, garantendo a tutti di essere davvero cittadini attivi e non con iniziative di sola facciata. Bisogna educare ad andare oltre, perché le barriere culturali sono le più difficili da superare. Bisogna mettere la persona al centro perché ogni individuo è una ricchezza.
Da parte sua, Verga ha risposto a una sollecitazione di Brivio - che lui ha detto di voler continuare a chiamare sindaco (con gli inevitabili sorrisi in sala: «Mai dire mai») - sulla differenza tra quel che oggi si chiama rigenerazione e un tempo cambio di destinazione d’uso: «Rigenerazione è soltanto una parola di moda. Quando quarant’anni fa proposi la mia legge si parlava di programmi integrati di intervento, poi di piani di ristrutturazione urbanistica e poi in altro modo ancora. Perché le città per continuare a essere città devono cambiare continuamente, sono il luogo del cambiamento per eccellenza, tutto il nuovo arriva dalle città, sia il bello che il brutto».
E, a proposito di bellezza, ha citato il cardinale Carlo Maria Martini: nel 1999 guardò al terzo millennio e al tema della bellezza ricordando il Dostoevskij della “bellezza che salverà il mondo”, ma si è chiesto “Quale bellezza?”. Solo la bellezza che si coniuga col bene. Lo sapeva già Francesco Sforza che cinquecento anni prima ordinò all’archistar dell’epoca, il Filarete, di progettare un grande ospedale che, tra le altre cose, fosse bello perché la bellezza aiuta a stare bene. Perché la bellezza, se c’è il bene, è il benessere delle città. Quella città viste come demoni e che sono il vero tema della politica del territorio. Al mondo, la metà della popolazione vive nelle città. E il fenomeno crescerà ancora di più. E Martini diceva che la città è il luogo dove si incontra la tolleranza.
Verga ha sottolineato come davvero il governo del territorio riguardi tutti perché l’urbanistica è la più alta concezione della politica, perché significa creare le condizioni di vita di una comunità. Un piano di governo del territorio può essere espressione di un’ideologia e quindi imponendo regole rigide o di una cultura e perciò tenendo conto del vissuto dell’intera società. Cinquant’anni fa c’era l’ideologia che le città dovessero diventare quelle cose schematiche che qualcuno diceva dovevano essere. Questo schema è saltato. Proprio qui. In Lombardia. Perché la nostra società lombarda ha una forza di propulsione dal basso incredibile. Nelle emergenze è la società che arriva prima. In un’alluvione, prima delle istituzioni arriva il vicino di cosa. E allora la logica è semplice. Il nuovo è ineluttabile e va guidato, esercitando la libertà responsabile e non le anarchie e cioè non faccio quel che voglio ma ciò che è utile, ciò che serve. E con un piano di governo del territorio la rigenerazione si può fare, anche se le regole dovrebbero essere più semplici perché in Italia abbiamo leggi che si contraddicono tra loro: sono state fatte leggi nuove senza abrogare quelle vecchie. Abbiamo bisogno di vivere e praticare un principio della nostra Costituzione, quello della sussidiarietà, un rapporto leale tra pubblico e privato. Pensando a ciò che già cinquant’anni fa diceva il primo presidente regionale Piero Bassetti che era avanti a tutti e cioè che il territorio è glocale. E oggi ce ne rendiamo conto. Nel proprio sistema locale ognuno è sicuro, è una comunità, mentre nell’individualismo c’è solo insicurezza.
A chi gli ha chiesto quale fosse l’ideologia dominante di oggi, Verga ha risposto indicando la finanza che va contrastata in ogni modo per ritornare alla cultura del lavoro.
Più tecnico l’intervento di Chiarolini concentrato proprio sul rapporto tra pubblico e privato. Ha illustrato le varie forme di possibile collaborazione tra finanza di progetto o leasing, ma ricordando come in ogni caso vadano previsti gli scenari del futuro, le scelte debbano essere accompagnate da rigorosi ragionamenti economici e sociali, il contraddittorio tra enti pubblici e società private debba essere aperto, gli sguardi convergenti, la collaborazione equilibrata, la necessità che ciascuno rispetti il proprio ruolo. Altrimenti, si rischia il fallimento. Occorre quindi confrontarsi sulle strategie: saper scegliere se un progetto sia giusto farlo in un luogo anziché in un altro non solo per il desiderio di un sindaco, di un assessore, di un imprenditore privato, ma tenendo conto delle condizioni oggettive anche di mercato. Considerazioni forse banali ma che vengono spesso trascurate.
Ha poi indicato le buone regole a cui gli amministratori dovrebbero attenersi: la lungimiranza, i trasferimenti del rischio, tener conto della sostenibilità economica e finanziaria del progetto, non si può andare all’arrembaggio e non solo gli enti pubblici ma anche i privati. Vero è che, oltre alle leggi che si sovrappongono, in Italia vi è anche un’eccessiva incertezza sui tempi che fa fuggire gli investitori. Concludendo quasi con una contraddizione: perché se ha parlato dell’’individualismo imperante di oggi che ha frammentato le comunità, anzi che le comunità non esistono proprio più, nel contempo ha contrapposto le caverne preistoriche alla competizione perché dove c’è competizione c’è civiltà. Spiegando che la competizione leale è un bene per tutti.
L’assemblea si è sciolta con una battuta di Brivio: «L’ostello in cui siamo è sorto dove c’era un vecchio cimitero. Più rigenerazione di così. Una risurrezione».
D.C.





















