SCAFFALE LECCHESE/266: il colera del 1855 in Brianza nel ''diario'' di un medico
«Quante volte ho sentito i contadini riferirmi minutamente le circostanze che accompagnarono la morte d’un loro parente, e aggiungere colla persuasione di chi sa di dire la verità, “il male cominciava a piegare al meglio, ma il signor dottore volle dargli l’ampollino e l’ammalato ne morì”. E i medici dovevano lottare contro un’opinione tanto sinistramente concepita». E spesso c’era chi esigeva che «il medico assaggiasse, egli il primo, la bevanda destinata all’infermo».
Così scriveva Ignazio Cantù nella sua storia brianzola del 1836 in pagine che lo studioso briviese dedicava alle epidemie di colera, un tempo frequenti. Se nell’immaginario popolare è la peste a rappresentare il flagello assoluto (e ne abbiamo peraltro parlato non molto tempo addietro) i testi storici ci dicono che anche il colera era una piaga che si portava via intere famiglie in un amen.
Sono, quelle del Cantù, le considerazioni che Vittorio Alessandro Sironi, neurochirurgo e docente di storia della medicina all’università milanese della Bicocca, ha scelto di porre a corredo di un proprio studio su Luigi Ripa (1820-1894), medico pavese della prima metà dell’Ottocento trasferitosi in Brianza, «un oscuro medico condotto (…) protagonista delle vicende sanitarie di una comunità», in particolare quella di Seregno.
Negli anni scorsi, Sironi aveva già prestato particolare attenzione alla storia della sanità in Brianza: ricordiamo per esempio “Medicina popolare in Brianza” pubblicato nel 1998 nella collana etnografica dell’editore lecchese Cattaneo. Ma anche “Medici e guaritori” pubblicato con l’editrice “La vita felice” nell’ottobre 2019, e cioè alla vigilia del diffondersi del covid, pandemia che aveva già seminato vittime e panico, quando nel 2020. Sironi dava alle stampe il suo lavoro su Ripa: “Un medico riformatore”, uscito anche questa volta per “La vita felice”. Si tratta di un libro che va oltre la semplice biografia, offrendoci qualche altra suggestione e una finestra sulla sanità brianzola nell’Ottocento
Come detto, Ripa era originario di Pavia dove nacque, crebbe, studiò e cominciò la sua attività di medico nel locale ospedale. Divenne poi medico condotto – ci informa Sironi - «non solo per le necessità contingenti dettate dal bisogno economico, ma anche per scelta, per vivere con maggiore intensità quella “dimensione sociale” della medicina avvertita come essenziale per il lavoro medico sin dagli anni dell’università».
Lasciata Pavia, arrivò nella Brianza “lecchese” nella condotta di cui facevano parte Tregolo, Brenno, Centemero, Samarino (tutte località che oggi rientrano nei confini di Costa Masnaga) e Nibionno. Vi si fermò poco. Nell’ottobre 1855, infatti, si trasferì a Seregno dove «in quasi trent’anni di lavoro ha saputo lasciare un impronta indelebile con le sue idee, le sue proposte e le sue soluzioni nel contesto cittadino, in tutta la Brianza e in ampia parte d’Italia». Non limitandosi ad assistere i pazienti ma impegnandosi per i miglioramenti dell’igiene, per una “medicina politica” – come scrive Sironi – per cui «la solidarietà verso il malato deve fare parte del bagaglio tecnico di ciascun medico, l’universalità della cura deve riguardare l’intera collettività di cui un sanitario si occupa e si preoccupa, l’unità nei confronti della persona deve essere il tratto distintivo di ogni impegno professionale». Motivo per il quale, nel 1864, fondò a Monza una sede della Croce Rossa.
Rimandando alla lettura del libro di Sironi per gli approfondimenti complessivi della figura di Luigi Ripa, a noi qui interessano il breve periodo “lecchese” e i suoi primi mesi da medico condotto tra Tregolo e Nibionno che furono non propriamente di ordinaria amministrazione: dovette infatti fronteggiare l’epidemia di colera che imperversò tra il 30 luglio e l’8 ottobre 1855. Sarebbe stata una delle tante epidemie che hanno caratterizzato la nostra storia e per la gran parte dimenticate o tutt’al più ricordate da qualche santella o qualche ex voto. Se non fosse che Ripa redasse una propria relazione da inviare al medico provinciale, pubblicata sulla Gazzetta medica per poi diventare un opuscolo che oggi definiremmo “instant-book” uscendo dalla Tipografia Chiusi di Milano in quello stesso 1855. Relazione praticamente dispersa o quasi, ma che oggi possiamo consultare agevolmente proprio grazie al libro di Sironi che la riproduce integralmente. Fu in una casa della località Samarino che «manifestavasi il coléra il 30 luglio nell'Agostino Bartesaghi, d' anni 5, che moriva in poche ore; poi nella casa Mauri, ove caddero inferme e morirono in poche ore la Teresa, d'anni 3 e l'Enrichetta d' anni 7; poi nei fratelli Riccardi; poi nella madre Riccardi, infermiera de' proprj figli; poi nella madre Mauri; poi nel Pirola, vicino di casa dei Riccardi».
Fu in una casa della località Samarino che «manifestavasi il coléra il 30 luglio nell'Agostino Bartesaghi, d' anni 5, che moriva in poche ore; poi nella casa Mauri, ove caddero inferme e morirono in poche ore la Teresa, d'anni 3 e l'Enrichetta d' anni 7; poi nei fratelli Riccardi; poi nella madre Riccardi, infermiera de' proprj figli; poi nella madre Mauri; poi nel Pirola, vicino di casa dei Riccardi».
E il medico deve fare i conti con i congiunti che non vogliono allontanarsi dai propri cari, finché la preoccupazione non diventa terrore: «L' occultazione dei malati e la caparbietà non permisero di subito isolarli e di passare le famiglie per le pratiche sanitarie. Cadevano a mano a mano colpiti quelli che avvicinavano i malati. Ben presto l'evidente figliazione persuase anche i più restii. Li vidi allora nel più desolante avvilimento pregarmi perché facessi trasportare i malati a salvare dall' eccidio la restante famiglia: vidi l'egoismo della propria salute in lotta co 'i più sacrosanti sentimenti di padre e di figlio, di moglie e di marito, di fratello e di sorella».
Samarino è una frazione di Tregolo, allora Comune autonomo, e conta 80 abitanti: «Trovasi in buona posizione, sur una collinetta, che prospetta parte della vaga vallata dei laghetti della Brianza, ma i coloni che la abitano sono in povera condizione, non so se perché dipendenti da chi non è troppo sollecito del loro bene; cattive le abitazioni, le corti, i portici vicini alle case sempre sucidi per letame ammucchiato; disordine sanitario nel contado che abbisogna di una radicale provvidenza».
Gli uomini sono agricoltori e le donne lavorano la seta. Le abitazioni dei coloni e dei poveri sono «anguste per le famiglie»: sudiciume nelle corti e nei portici, troppo vicine ai letamai, «i piani terreni per lo più sono umidi, spesso fangosi, perché quasi tutti non pavimentati di mattoni; e i piani terreni sono quelli abitualmente abitati».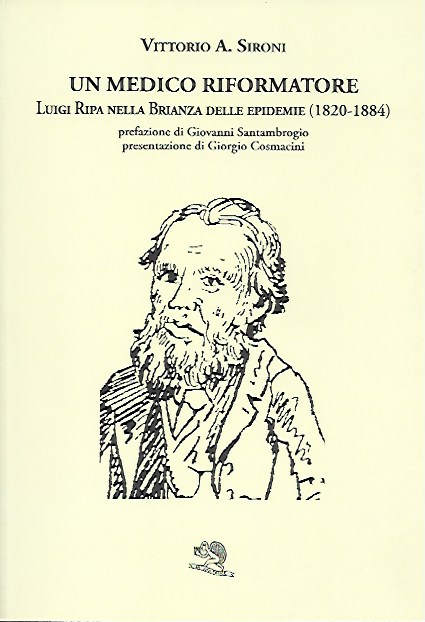 Sono considerazioni importanti, perché l’allora ancor giovane medico ha il sospetto che tra colera e condizioni igieniche vi sia un legame. Due secoli fa non era chiaro come lo è oggi. Lo dice egli stesso: «Non conosciamo il veleno specifico coleroso - per quale veicolo avvenga la trasmissione come aggredisca l'organismo. È presunzione, che può avvicinarsi al vero, sia esso assorbito specialmente per l'atrio respiratorio polmonare più che per quello della cute e portato nel circolo sanguigno.» Come non erano ancora chiari i provvedimenti per arginare il contagio e Ripa ne dà conto: «Si videro venire in iscena li argumenti della ciarlataneria e de più compassionevoli pregiudizj: il vino con la fuligine e l'olio: le bevande di vino con uova, empiastri e manicaretti di aglio, cipolla, per uso esterno ed interno».
Sono considerazioni importanti, perché l’allora ancor giovane medico ha il sospetto che tra colera e condizioni igieniche vi sia un legame. Due secoli fa non era chiaro come lo è oggi. Lo dice egli stesso: «Non conosciamo il veleno specifico coleroso - per quale veicolo avvenga la trasmissione come aggredisca l'organismo. È presunzione, che può avvicinarsi al vero, sia esso assorbito specialmente per l'atrio respiratorio polmonare più che per quello della cute e portato nel circolo sanguigno.» Come non erano ancora chiari i provvedimenti per arginare il contagio e Ripa ne dà conto: «Si videro venire in iscena li argumenti della ciarlataneria e de più compassionevoli pregiudizj: il vino con la fuligine e l'olio: le bevande di vino con uova, empiastri e manicaretti di aglio, cipolla, per uso esterno ed interno».
La malattia d'altronde è considerata castigo di Dio per avere peccato contro il suo volere e quindi per poterla frenare «anziché l'isolamento» si ricorre alle «processionali santocchierie notturne ai cimiteri» con «l’accalcamento nella chiesa, negli oratori». Finché, «li esiti fortunati che si ebbero negli altri communi servirono di lezione. Il popolo conobbe che aveva più ragione il medico che i deputati. Negli ultimi giorni si dispose anche un ritiro, cui si diede il nome di ospitale. Il locale eccellente; ma la descrizione della gestione formerebbe un giocoso episodio a questa tragedia, della quale fortunatamente fu l'ultima scena».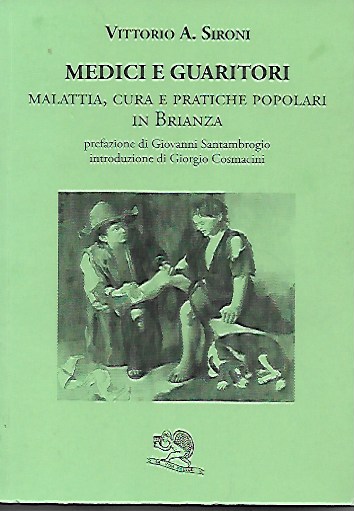 Il fatto è che le conoscenze mediche a metà del XIX secolo sono quelle sono. Praticamente non si sa niente: si improvvisa, si esperimenta, come sempre vanno alla grande i salassi spesso deleteri, si prova con il rum, ci si arrovella tra bagni freddi e bagni caldi. A contare era soprattutto la fortuna. Annota Ripa: «Prescrissi in via di esperimento dodici polveri di 114 di grano di oppio e 112 grano di valerianato di chinina da prendersene una ogni tre ore, che replicai una seconda volta con l'oppio ed una terza senza l'oppio, dieta assoluta, bevanda zuccherata ghiacciata. A poco a poco dietro l'uso di quelle polveri cessò l'inquietudine, cessò la diarrea, si rialzò la voce, si ricomposero i tratti della fisionomia e guarì perfettamente. Era l'oppio, era il valerianato di zinco o di chinina che giovavano, od ambo e due contemporaneamente?». E poi la cosiddetta emulsione arabica. E ancora «ho veduto far ingollare ad un coleroso nello stato convulsivo asfittico a cucchiajate la seguente mistura: succo di limone, acqua distillata di cedro, laudano. (…) Ho veduta e sentita la pratica di far ingollare in poche sorsate ad un coleroso una dramma di laudano in una libra di infuso di camomilla caldo».
Il fatto è che le conoscenze mediche a metà del XIX secolo sono quelle sono. Praticamente non si sa niente: si improvvisa, si esperimenta, come sempre vanno alla grande i salassi spesso deleteri, si prova con il rum, ci si arrovella tra bagni freddi e bagni caldi. A contare era soprattutto la fortuna. Annota Ripa: «Prescrissi in via di esperimento dodici polveri di 114 di grano di oppio e 112 grano di valerianato di chinina da prendersene una ogni tre ore, che replicai una seconda volta con l'oppio ed una terza senza l'oppio, dieta assoluta, bevanda zuccherata ghiacciata. A poco a poco dietro l'uso di quelle polveri cessò l'inquietudine, cessò la diarrea, si rialzò la voce, si ricomposero i tratti della fisionomia e guarì perfettamente. Era l'oppio, era il valerianato di zinco o di chinina che giovavano, od ambo e due contemporaneamente?». E poi la cosiddetta emulsione arabica. E ancora «ho veduto far ingollare ad un coleroso nello stato convulsivo asfittico a cucchiajate la seguente mistura: succo di limone, acqua distillata di cedro, laudano. (…) Ho veduta e sentita la pratica di far ingollare in poche sorsate ad un coleroso una dramma di laudano in una libra di infuso di camomilla caldo».
Essendo una relazione medica, Ripa si sofferma a lungo sui sintomi riscontrati non sempre simili, sul decorso della malattia dissimile da un paziente all’altro, sulla diffusione del contagio, tutti elementi utili appunto a chi deve prendere decisioni in caso di epidemie.
Ma il «medico condotto – è l’amaro commento - è tutt' altro che un ufficiale sanitario. I membri costituenti le Deputazioni comunali in generale hanno nessuna stima di lui, nessuna considerazione come membro sanitario. Il medico condotto non è che un salariato per i poveri e per i ricchi. Ed è per questo che si disconoscono i servigi che un medico condotto presta; ed è per questo che i medici condotti trovansi compressi sotto il martirio di una posizione che non è la loro, di una vita senza colore. Mai che si comunichi al medico condotto un’istruzione, una ordinanza, una circolare o altro in oggetto sanitario, che la Magistratura superiore invia alle Deputazioni. E nelle gravi emergenze i Commissariati Distrettuali fanno appello allo zelo ed alla responsabilità de' medici condotti!».
Eppure, l’umile medico condotto improvvisa degli ospedali, un cordone sanitario per arginare il contagio, si inventa rimedi, cercando di muoversi con cautela e discrezione: «Io temeva infatti l'atmosfera che circonda il coleroso costituita dalle esalazioni dei polmoni, della cute, delle materie emesse per vomito e per secesso, e, quando poteva, teneva agli atrj della respirazione un fazzoletto impregnato d' aceto canforato. Racconto senza dare nessuna importanza. Ho mai avuto fede nel soprabito di tela cerata. Mette in apprensione i malati e i sottoposti panni si impregnano egualmente dei gas di quella atmosfera.» e precisa «che li isolamenti dei malati, la disinfettazione delle stanze, delle robe che appartennero ai malati e li altri provedimenti sanitarj devono essere rigorosi anche nel primo stadio, ritenuti mezzi sicuri che limitano il difundersi della malatia». Inoltre, offre consigli anche alle autorità, non mancando d’ironia: «In Brianza come si difetta di acqua, in generale, si difetta di ghiaccio, sustanza indispensabile e come mezzo igienico e come mezzo terapeutico. È estremamente sentito il bisogno di qualche ghiacciaia comunale. E la spesa, giacché è d' uopo parlare anche di questa quando non si tratti di appendere sei o otto belle campane nuove su la torre della chiesa, sarebbe poca, inconcludente, qualora si unissero ad incontrarla tre, quattro, sei communi. Del resto il povero contadino, che si presta si volonteroso a lavorare anche la festa, gratuitamente, per l'appalto della chiesa, non si rifiuterebbe certo al lavoro di condur ghiaccio per empirla, che gli si potrebbe far conoscere ridondare a suo profitto». E ancora: «Un altro provvedimento da suggerire. In quei comuni poco previdenti dai quali non si sa trarre partito da qualche fonte perenne per costruire pubblici lavatoi, ne’ quali l’acqua sia opportunamente raccolta per tale scopo, col cambio quando dalle lavature trovasi lorda, la pulitezza delle lingerie quindi la mondezza del corpo è molto trasandata».
Inoltre, offre consigli anche alle autorità, non mancando d’ironia: «In Brianza come si difetta di acqua, in generale, si difetta di ghiaccio, sustanza indispensabile e come mezzo igienico e come mezzo terapeutico. È estremamente sentito il bisogno di qualche ghiacciaia comunale. E la spesa, giacché è d' uopo parlare anche di questa quando non si tratti di appendere sei o otto belle campane nuove su la torre della chiesa, sarebbe poca, inconcludente, qualora si unissero ad incontrarla tre, quattro, sei communi. Del resto il povero contadino, che si presta si volonteroso a lavorare anche la festa, gratuitamente, per l'appalto della chiesa, non si rifiuterebbe certo al lavoro di condur ghiaccio per empirla, che gli si potrebbe far conoscere ridondare a suo profitto». E ancora: «Un altro provvedimento da suggerire. In quei comuni poco previdenti dai quali non si sa trarre partito da qualche fonte perenne per costruire pubblici lavatoi, ne’ quali l’acqua sia opportunamente raccolta per tale scopo, col cambio quando dalle lavature trovasi lorda, la pulitezza delle lingerie quindi la mondezza del corpo è molto trasandata».
Terminato il lavoro, «pensai al mio interesse» e «domandai alle Deputazioni la liquidazione della diaria e per retribuzione e per rimborso delle spese, circa austriache lire 600, somma non indifferente per la borsa di un medico condutto, che portò quale peccato originale imperdonabile il solo cervello per patrimonio. e mi venne risposto che bisognava aspettare…».
Così scriveva Ignazio Cantù nella sua storia brianzola del 1836 in pagine che lo studioso briviese dedicava alle epidemie di colera, un tempo frequenti. Se nell’immaginario popolare è la peste a rappresentare il flagello assoluto (e ne abbiamo peraltro parlato non molto tempo addietro) i testi storici ci dicono che anche il colera era una piaga che si portava via intere famiglie in un amen.
Sono, quelle del Cantù, le considerazioni che Vittorio Alessandro Sironi, neurochirurgo e docente di storia della medicina all’università milanese della Bicocca, ha scelto di porre a corredo di un proprio studio su Luigi Ripa (1820-1894), medico pavese della prima metà dell’Ottocento trasferitosi in Brianza, «un oscuro medico condotto (…) protagonista delle vicende sanitarie di una comunità», in particolare quella di Seregno.
Negli anni scorsi, Sironi aveva già prestato particolare attenzione alla storia della sanità in Brianza: ricordiamo per esempio “Medicina popolare in Brianza” pubblicato nel 1998 nella collana etnografica dell’editore lecchese Cattaneo. Ma anche “Medici e guaritori” pubblicato con l’editrice “La vita felice” nell’ottobre 2019, e cioè alla vigilia del diffondersi del covid, pandemia che aveva già seminato vittime e panico, quando nel 2020. Sironi dava alle stampe il suo lavoro su Ripa: “Un medico riformatore”, uscito anche questa volta per “La vita felice”. Si tratta di un libro che va oltre la semplice biografia, offrendoci qualche altra suggestione e una finestra sulla sanità brianzola nell’Ottocento
Come detto, Ripa era originario di Pavia dove nacque, crebbe, studiò e cominciò la sua attività di medico nel locale ospedale. Divenne poi medico condotto – ci informa Sironi - «non solo per le necessità contingenti dettate dal bisogno economico, ma anche per scelta, per vivere con maggiore intensità quella “dimensione sociale” della medicina avvertita come essenziale per il lavoro medico sin dagli anni dell’università».

Vittorio Alessandro Sironi
Lasciata Pavia, arrivò nella Brianza “lecchese” nella condotta di cui facevano parte Tregolo, Brenno, Centemero, Samarino (tutte località che oggi rientrano nei confini di Costa Masnaga) e Nibionno. Vi si fermò poco. Nell’ottobre 1855, infatti, si trasferì a Seregno dove «in quasi trent’anni di lavoro ha saputo lasciare un impronta indelebile con le sue idee, le sue proposte e le sue soluzioni nel contesto cittadino, in tutta la Brianza e in ampia parte d’Italia». Non limitandosi ad assistere i pazienti ma impegnandosi per i miglioramenti dell’igiene, per una “medicina politica” – come scrive Sironi – per cui «la solidarietà verso il malato deve fare parte del bagaglio tecnico di ciascun medico, l’universalità della cura deve riguardare l’intera collettività di cui un sanitario si occupa e si preoccupa, l’unità nei confronti della persona deve essere il tratto distintivo di ogni impegno professionale». Motivo per il quale, nel 1864, fondò a Monza una sede della Croce Rossa.
Rimandando alla lettura del libro di Sironi per gli approfondimenti complessivi della figura di Luigi Ripa, a noi qui interessano il breve periodo “lecchese” e i suoi primi mesi da medico condotto tra Tregolo e Nibionno che furono non propriamente di ordinaria amministrazione: dovette infatti fronteggiare l’epidemia di colera che imperversò tra il 30 luglio e l’8 ottobre 1855. Sarebbe stata una delle tante epidemie che hanno caratterizzato la nostra storia e per la gran parte dimenticate o tutt’al più ricordate da qualche santella o qualche ex voto. Se non fosse che Ripa redasse una propria relazione da inviare al medico provinciale, pubblicata sulla Gazzetta medica per poi diventare un opuscolo che oggi definiremmo “instant-book” uscendo dalla Tipografia Chiusi di Milano in quello stesso 1855. Relazione praticamente dispersa o quasi, ma che oggi possiamo consultare agevolmente proprio grazie al libro di Sironi che la riproduce integralmente.

E il medico deve fare i conti con i congiunti che non vogliono allontanarsi dai propri cari, finché la preoccupazione non diventa terrore: «L' occultazione dei malati e la caparbietà non permisero di subito isolarli e di passare le famiglie per le pratiche sanitarie. Cadevano a mano a mano colpiti quelli che avvicinavano i malati. Ben presto l'evidente figliazione persuase anche i più restii. Li vidi allora nel più desolante avvilimento pregarmi perché facessi trasportare i malati a salvare dall' eccidio la restante famiglia: vidi l'egoismo della propria salute in lotta co 'i più sacrosanti sentimenti di padre e di figlio, di moglie e di marito, di fratello e di sorella».
Samarino è una frazione di Tregolo, allora Comune autonomo, e conta 80 abitanti: «Trovasi in buona posizione, sur una collinetta, che prospetta parte della vaga vallata dei laghetti della Brianza, ma i coloni che la abitano sono in povera condizione, non so se perché dipendenti da chi non è troppo sollecito del loro bene; cattive le abitazioni, le corti, i portici vicini alle case sempre sucidi per letame ammucchiato; disordine sanitario nel contado che abbisogna di una radicale provvidenza».
Gli uomini sono agricoltori e le donne lavorano la seta. Le abitazioni dei coloni e dei poveri sono «anguste per le famiglie»: sudiciume nelle corti e nei portici, troppo vicine ai letamai, «i piani terreni per lo più sono umidi, spesso fangosi, perché quasi tutti non pavimentati di mattoni; e i piani terreni sono quelli abitualmente abitati».
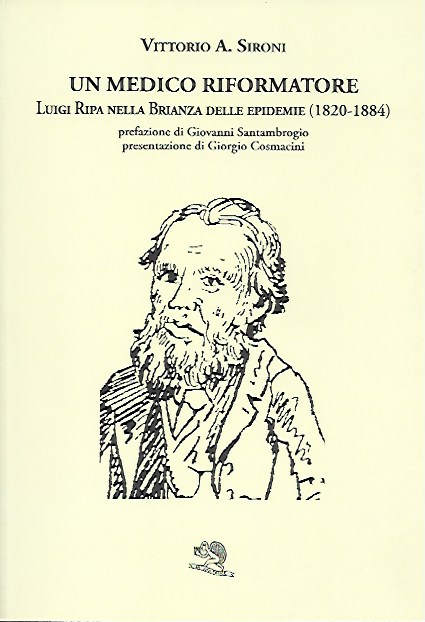
La malattia d'altronde è considerata castigo di Dio per avere peccato contro il suo volere e quindi per poterla frenare «anziché l'isolamento» si ricorre alle «processionali santocchierie notturne ai cimiteri» con «l’accalcamento nella chiesa, negli oratori». Finché, «li esiti fortunati che si ebbero negli altri communi servirono di lezione. Il popolo conobbe che aveva più ragione il medico che i deputati. Negli ultimi giorni si dispose anche un ritiro, cui si diede il nome di ospitale. Il locale eccellente; ma la descrizione della gestione formerebbe un giocoso episodio a questa tragedia, della quale fortunatamente fu l'ultima scena».
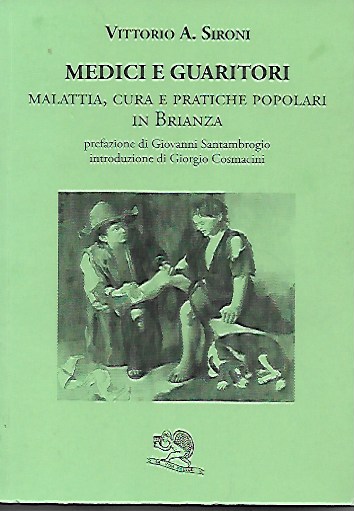
Essendo una relazione medica, Ripa si sofferma a lungo sui sintomi riscontrati non sempre simili, sul decorso della malattia dissimile da un paziente all’altro, sulla diffusione del contagio, tutti elementi utili appunto a chi deve prendere decisioni in caso di epidemie.
Ma il «medico condotto – è l’amaro commento - è tutt' altro che un ufficiale sanitario. I membri costituenti le Deputazioni comunali in generale hanno nessuna stima di lui, nessuna considerazione come membro sanitario. Il medico condotto non è che un salariato per i poveri e per i ricchi. Ed è per questo che si disconoscono i servigi che un medico condotto presta; ed è per questo che i medici condotti trovansi compressi sotto il martirio di una posizione che non è la loro, di una vita senza colore. Mai che si comunichi al medico condotto un’istruzione, una ordinanza, una circolare o altro in oggetto sanitario, che la Magistratura superiore invia alle Deputazioni. E nelle gravi emergenze i Commissariati Distrettuali fanno appello allo zelo ed alla responsabilità de' medici condotti!».
Eppure, l’umile medico condotto improvvisa degli ospedali, un cordone sanitario per arginare il contagio, si inventa rimedi, cercando di muoversi con cautela e discrezione: «Io temeva infatti l'atmosfera che circonda il coleroso costituita dalle esalazioni dei polmoni, della cute, delle materie emesse per vomito e per secesso, e, quando poteva, teneva agli atrj della respirazione un fazzoletto impregnato d' aceto canforato. Racconto senza dare nessuna importanza. Ho mai avuto fede nel soprabito di tela cerata. Mette in apprensione i malati e i sottoposti panni si impregnano egualmente dei gas di quella atmosfera.» e precisa «che li isolamenti dei malati, la disinfettazione delle stanze, delle robe che appartennero ai malati e li altri provedimenti sanitarj devono essere rigorosi anche nel primo stadio, ritenuti mezzi sicuri che limitano il difundersi della malatia».

Terminato il lavoro, «pensai al mio interesse» e «domandai alle Deputazioni la liquidazione della diaria e per retribuzione e per rimborso delle spese, circa austriache lire 600, somma non indifferente per la borsa di un medico condutto, che portò quale peccato originale imperdonabile il solo cervello per patrimonio. e mi venne risposto che bisognava aspettare…».
Dario Cercek




















